Viaggio in Albania 1939 (4)
Viaggio in Albania[1]
Quarta parte
Fototesto del nostro inviato Lamberti Sorrentino
Tirana, dicembre.
M’ero perduto per le vie di Scutari. Accanto a me c’erano tre artiglieri, giovani, con le divise nuove nuove; e ad essi domandai quale strada mi avrebbe condotto all’albergo. Si guardarono in volto, perplessi; intanto avevano corretto la posizione, quasi io fossi un ufficiale. Stettero a guardarmi, preoccupati ora: finalmente uno di loro tentò di rispondermi in italiano: non più di dieci parole, certo, ne sapeva, e così m’accorsi che quei tre erano soldati albanesi. Non avevano nulla, nel volto o nell’uniforme, che li distinguesse dai nostri. Erano sereni e contenti. Me li guardai a lungo, ché ne valeva la pena. Erano irriconoscibili nel loro paese, come lo sono quelli della guardia reale albanese a Roma: si sta loro vicini, in tram o nelle strade, e si scambiano per italiani. A Roma, vi sono due battaglioni di queste guardie reali, che sfilano nei giorni di festa in gonnellino e fez bianchi, o con calzoni diritti ed attillati fino al piede e fez rossi. Albanesi del nord e del sud, con un colonnello italiano e subalterni propri, confusi a Roma nella folla. In Albania l’esercito ha istruttori misti; cosicché con la disciplina e la pratica militare, imparano anche la lingua. Soldati veri, militari nati, gli albanesi hanno capito che l’appartenere ad un esercito serio e regolare significa creare un’armata nazionale, alla quale s’appartiene per diritto di leva, non per dovere di servitù al tale o tal altro signorotto: un’aspirazione centenaria. La divisa li inorgoglisce; avere sul bavero le stellette li impegna ad una dignità che li affina, in servizio e fuori. Dopo qualche tempo si fa l’occhio; e soltanto un ufficiale istruttore che sia qui fin dai primi giorni dell’unione si vanta di distinguerli da lontano. Ma la sorpresa maggiore l’ho avuta quando ho incontrato i carabinieri albanesi, ignari dell’italiano, con il V.E. sulla coccarda tricolore fermata nel tricorno.
La radio Tirana trasmette, oltre i bollettini, programmi di musica d’ogni genere. Specialmente si trasmette il canzoniere nazionale, ricco e interessante; vi sono numerosi artisti che hanno compiuto gli studi di canto in Italia e la cui aspirazione è di far conoscere nelle nostre città i canti che esprimono l’anima albanese.
A Scutari ho visitato le caserme della milizia albanese. Una casa adattata a caserma, un giardino che sta allargandosi; nell’atrio una decina di malissori, scutarini della montagna, tipi bellissimi, robusti ed agili, di una mascolinità perfetta. Vestivano il costume malissoro, con fasce, stivali e fazzoletto colorati. Il console comandante teneva loro discorsi spicci: lo ascoltavano e lo comprendevano, si vedeva.
— Ve lo dissi nel villaggio: la milizia è per tutti gli albanesi, per tutti coloro — che sono disposti a dare senza chiedere. Più che diritti, tra noi, ci sono doveri. In qualsiasi momento potrete esser chiamati in servizio per lavorar o combattere, così come sta bene a un milite; potrete esser chiamati anche per far atto di presenza. Nella milizia ci vogliono uomini seri, gente disposta a tutto: chi non se la sente stia a casa, chi viene da noi, entrerà in una grande famiglia. Sapete ora che il fascismo è una rivoluzione: voi ne sarete la guardia armata da questo lato dell’Adriatico. Mi piace ripetervelo, e mi piace che voi ricordiate: non sarà una vita comoda. Non si sforza nessuno: potete ancora tornarvene a casa: chi vuol andarsene, vada e se ne stia tranquillo: amici quanto prima. Se passerò nel suo villaggio andrò lo stesso a bere il suo caffè e a fumare la sua sigaretta. Pensateci bene. Interprete, traduci.
Mentre l’interprete ripeteva il discorso in albanese, gli uomini facevano sì o no con il capo, annuendo; il discorso era di loro gusto. Guardarono in faccia il console, e poi si misero a discutere tra loro, in gruppo serrato. Infine il loro portavoce, un capo di villaggio, disse in italiano:
— Ci arruoliamo tutti. E ti manderemo gli altri uomini del nostro villaggio. Sta bene: vogliamo servire nella milizia e avere per grande capo Mussolini. Ma non vogliamo avere per capo... — e qui nomina un tirannello locale che li tartassava da anni.
Questo dei capi locali è il lamento delle popolazioni albanesi della montagna e della pianura. I contadini hanno dovuto abituarsi a vedere lo stato nella persona di un piccolo feudatario che ha premuto fortemente e ingiustamente, spesso per interessi personali. Di questi capi, adesso che la giustizia italiana è sul posto, gli albanesi non vogliono più saperne: si fanno militi, si iscrivono nel partito, sperano — oltre tutto — che il dinamismo sociale e politico della nuova organizzazione travolga certe vecchie gerarchie fuori clima, oggi anacronistiche, e dannose. È questione di tempo: gli albanesi che entrano nelle file del partito, nell’esercito, nella milizia, formano la base dello stato popolare: e a mano a mano che il livello della piramide sale, le vecchie gerarchie decadono: si va spontaneamente e irresistibilmente costruendo un ordine nuovo: sia come fatto morale, sia come sostituzione di antichi valori, o come ringiovanimento dei quadri di comando.
Nelle principali città albanesi vi è un ufficio turistico, attrezzato a somiglianza dei migliori uffici della “Cit” in Italia. Personale specializzato è a disposizione del pubblico: gli uffici turistici di Tirana, di Durazzo, possono in mezz’ora fornire al passeggero tutti i biglietti necessari per fare un viaggio in Giappone o alle Hawaii.
Non dimenticare Padre Valentini, se vai a Scutari. — Io diffido dei benemeriti; e non sarei andato nel collegio gesuita se un certo raro materiale informativo non si fosse trovato soltanto lì.
“Andiamo a vedere questo benefattore”, dissi fra me e me. Attraverso una serie di stradette, entrai in un portone, e fui nell’eco di un coro mesto e lento. — C’è Padre Valentini? — Passate. Campanello, bussola, corridoio: altro corridoio, un atrio, un giardino ancora, una scala; poi una porta a vetri: si girava da dieci minuti. Il converso bussa discretamente con le nocche. Pioveva a dirotto: — Avanti — in fondo alla camera una grande vetrata che prendeva tutta la parete di fronte, era immersa nella pioggia; s’udiva l’eco sorda dei canali e delle grondaie. Nella prospettiva grigia dell’annottare vicino, l’ombra degli alberi appariva attraverso i vetri fradici, misteriosa e ondeggiante. Poi sentii l’odore dei libri, di tanti libri messi assieme. I libri hanno solo bisogno di tempo, più che di spazio, per formare quelle società costituite che si chiamano biblioteche: sia caldo, freddo, umido o asciutto, non importa. Questa biblioteca aveva per me anche il pregio del disordine: o almeno di un ordine naturale, non portato al grado di abito mentale, di vizio, che rovina tutto. Questa biblioteca è abitata, consultata, attiva. L’orgasmo di un’officina non m’avrebbe stordito come il palpito di vita che mi venne, dopo quindici giorni di viaggio per campagne e paesi primitivi, da quei libri. Quasi non mi avvidi che un prete mi guardava con la mano tesa: c’era un poco di malizia nei suoi occhi queti, ispessiti dalle lenti. La sua mano era calda e asciutta: sentii amico lui, amico lo studio e una gran voglia di sedermi e di non muovermi. Fu in quello stanzone che pensai alla primitività dell’Albania, della terra e degli uomini; da quell’oasi di libri, fresca e accogliente, sentii che il paese che m’era attorno, che finivo di visitare, era tutto genuino, allo stato grezzo. Fu il contrasto tra quell’ambiente tutto spirito, e quel che avevo visto tutto istinto, a rivelarmi una verità. Ne ebbi un’impressione indefinibile che mi avvicinò a questa terra per sempre: tutto quello che mi aveva sorpreso e sbigottito divenne chiaro e facile. Mi sembrò di ritrovar finalmente, gli albanesi, trovai alcuna affinità di senso del tradizionale della mia gente sulle montagne del salernitano, e quello degli albanesi. Capii che tali affinità sono determinate dai contatti mantenuti da certi popoli con i secoli passati, con gli evi remoti: quando vi erano leggi elementari, più o meno le stesse per tutti; e i popoli, anche senza conoscersi, si somigliavano.
Due lampi illividirono le vetrate: ci accorgemmo così che era calata la sera. Suonò una campanella in uno degli edifici del convento. Padre Valentini accese la luce elettrica: sotto i miei occhi passò una collezione di monete antiche trovate in Albania, delle fotografie prese dal Padre nelle sue gite in montagna, manoscritti di diplomatici veneziani in Turchia, quando Venezia era un popolo e una nazione, riguardanti l’Albania.
L'albanese ama la famiglia, è legato alla casa, alla terra. Molti albanesi hanno dovuto emigrare, per procacciarsi il pane d'ogni giorno, in paesi lontani; ma non abbandonano le loro tradizioni. Generalmente ritornano col tempo in patria.
— Parlate albanese, Padre? — gli domandai.
— Come l’italiano — fu la risposta: — anzi, meglio dell’italiano. Sono qui da quindici anni, e predico in albanese. Ora mi viene meno spontaneo predicare in italiano. Sì — mi disse poco dopo — sono veneto, e qui mi sembra di starvene a casa. Il passato storico ha un enorme valore, non soltanto per le collettività, ma anche per l’individuo.
— Non potreste più lasciarla. Non potreste più lasciarla, l’Albania? — chiesi. Mi guardò perplesso: le mie parole gli si affacciarono alla mente prospettandogli, forse, una possibilità che ancora non avea mai pensato. Quel Padre che adopra la Leica e raccoglie monete antiche, che insegna, dirige, scrive, e soprattutto studia, e soprattutto occupa questa biblioteca dove è bello arrivare, ma dove sarebbe meglio fermarsi; questo Padre Valentini mi sembra un uomo completo. Fra lui e un condottiero di eserciti non vi è poi grande differenza: per il secondo vale ciò che accade attorno a lui, fuori di lui: per il primo, ha valore quello che avviene dentro, nella coscienza.
Suonò un’altra campana: — Adesso dovete andarvene; vado al refettorio — mi disse dolcemente. Aggiunse sulla soglia: — Tornate.
Fuori non trovai una carrozza; non avevo ombrello e cappello; e l’acqua mi entrò nel collo, m’intrise.
Ecco il Drin in piena, peggio dell’anno passato, peggio degli altri anni. Si dice che il povero contadino albanese non lavora, che l’albanese non ama la terra. Ma perché lavorare? Coltivi terra, semini granoturco, poi viene Drin e porta via tutto.
Questo è un lamento mesto di un agricoltore di Alessio, fatto a me, fermo con la macchina, sull’orlo della strada metà allagata; qui, seduto sui talloni, l’uomo si riconosceva innocente di ciò che gli stava capitando. Per me era impossibile avanzare. L’agricoltore guardava l’acqua salire, lentamente; era ormai a un metro da lui, e tra poco lo avrebbe raggiunto, lo avrebbe respinto più indietro. L’altra riva era a oltre un chilometro; la piena aveva trasformato un fiume modesto in una immensa, tumultuosa arteria incupita, piagata di vortici, con larghe chiazze di fango, irta di alberi divelti e di detriti d’ogni genere. In un villaggio vicino l’acqua era arrivata improvvisa, la notte, nelle stanze terrene. Gli uomini erano lontani, a lavorare certo sulle strade: le donne salirono sui tetti, aggrappate ai comignoli, con i bambini. I nostri militi giunsero poco in barca, per salvarle; non vollero; accettarono appena i viveri di soccorso, vergognose di doversi mostrare a gente estranea, mentre i loro uomini erano lontani. Vi furono morti e dispersi. Il contadino, con malinconia, racconta che a cento metri a valle è stata rinvenuta una culla vuota. — E il bimbo? Egli indica l’acqua che ora gli lambisce i piedi, e con spavento amaro dice una sola parola: — Drin. Sono arrivato fin qui da Scutari, avanzando a fatica: frequenti i tratti di strada sommersi: in alcuni punti l’acqua lambì il cofano. E’ giorno di mercato, a Scutari, e da trenta chilometri d’attorno vengono contadini e montanari con gli asinelli carichi; non mancano le donne. Uomini, donne, animali avanzano faticosamente e fatalisticamente; l’inondazione tocca il ginocchio. Nella mattinata grigia, tutta grigia da un capo all’altro dell’orizzonte, questa gente rassegnata cammina nell’acqua senza dar segni di stanchezza o di sorpresa, senza un lamento o una bestemmia. Fu sempre così nei secoli: da quando esiste la memoria del popolo albanese, le generazioni si son passate la convinzione che nel mese di dicembre, quando il Drin straripa, si debbono fare i conti con l’acqua, divenuta di colpo padrona delle strade e delle cose: e che è fatale camminarvi dentro fino al ginocchio, passar le notti sui tetti: con i bambini che piangono, a spiar che questa acqua cattiva si ritiri. Qualche volta l’acqua ruba alle case una culla, con il bimbo dentro, e lo porta a morire lontano. In ogni alba di dicembre si guarda, sui tronchi d’albero, i segni lasciati dall’acqua sulla scorza, per sapere se il livello salirà ancora o scenderà.
Il partito Fascista Albanese, e la Milizia Fascista Albanese, sono creazioni tipiche dell’Impero; a traverso queste organizzazioni che in terra schipetara ripetono le esperienze della Madre Patria, la rivoluzione si innesta, come morale e come potenza, nel corpo del nuovo Regno legato alla Corona dei Savoia. I giovani albanesi che prima dell’unione vivevano nella strada, oggi sono fieri di appartenere alle nostre organizzazioni. I genitori si inquadrano anche essi nella Milizia.
L’abitato ci venne incontro con un brusio di luci e di voci: le luci erano fioche, le voci allegre. La macchina si arrestò davanti a un caffè, illuminato da una lampadina rossastra dimenticata da chissà quando proprio in mezzo al soffitto. Ne cadeva una luce d’occasione, lugora, stinta, la quale fondeva in un blocco di pece mobile, gli avventori: una dozzina di militi, che, al nostro arrivo, si fecero sulla porta. Innestai la radio. Uno dei passeggeri, un federale albanese, se doveva telefonar da quel paese per farsi venire incontro dalla capitale la macchina propria. Nella Plymouth adibita al servizio pubblico Scutari-Tirana, un macchinone del tempo di Zog, eravamo in otto, compreso l’autista; tre sul sedile posteriore, tre sugli strapuntini; davanti s’era in due: l’autista ed io, che, per rimanere solo, avevo pagato tariffa doppia. Innestai la radio, ma fu l’autista albanese a trovare l’onda. — Questa è Sofia — disse soddisfatto. Era una canzone complicata, a quattro voci.
L’audizione fu interrotta da una voce che mi soffia nel volto e mi rintrona nell’orecchio: — C’è posto? — Nel finestrino si inquadra il capo di un milite. Sento l’odore del suo corpo accaldato. L’autista albanese parla di balestra, parla di balestre, siamo in otto. — C’è posto? — ripetè il milite fissandomi. E alla lucetta viola della radio distinguo i suoi tratti regolari, vedo bruciare i suoi occhi: — Non senti? Dice che è completo. — Un pochino di posto, appena un pochino, debbo arrivare a Durazzo, mi lasciate al bivio; se arrivo stasera prendo il vapore, se perdo il vapore perdo un giorno: pago quello che volete. — Vieni sù — dico al milite, e siede accanto a me. Con il milite è entrata nella macchina un’energia calma ed elementare. L’autista ed io, stringendoci, sentiamo il peso della nuova persona che è con noi. Cerco di sorprenderlo, nella corsa, mediante la radio; egli ascolta silenzioso, guarda sopra le spade luminose dei fari. Ha il tascapane sulle ginocchia, occupa quanto meno posto è possibile. Gli offro una sigaretta, gliela accendo. — Licenza? — Sì, ma veramente non so di che si tratta. Ero al lavoro, da quattro giorni la mia compagnia è addetta ai lavori stradali. Ci hanno promesso una paga. Però non è per la paga, che noi si lavora. Per obbedire. Quel che comandano i superiori sta bene. Erano le quattro e il furiere mi ha detto che c’era la licenza per me. Che storie, non sfottere, furiere, gli ho detto. Le licenze sono sospese. E lui ha insistito, mi ha portato dal signor Centurione: ed è vero, dieci giorni di licenza, partire subito. Madonna santissima, se le licenze sono chiuse, ditemi, signor Centurione, ditemi, allora, c’è qualcosa? Il signor centurione mi ha giurato che tutto andava bene; che c’è un ordine, da Lecce; protezioni forse. Ma quali protezioni; mia moglie, poverina, non conosce nessuno, meno l’agente Luigino, ch’è mio amico. Però: può un agente far avere una licenza straordinaria? Non ho visto, non ho capito più niente. I compagni a confortarmi. Uno mi ha mostrato una lettera dal mio paese, in provincia di Lecce, di sua moglie, che conosce anche mia moglie, e non dice niente. La lettera è di una settimana. Infine, mi sono un po’ confortato. Se stasera prendo il postale a Durazzo, domani a mezzogiorno sono a casa. Nell’automobile è tornato il silenzio. L’autista albanese porge anche lui una sigaretta al milite, e gli spiega che al bivio di Durazzo ci saremo tra un’ora: al bivio passano macchine provenienti da Tirana: qualcuna ne troverà; lo consiglia: — A sera le macchine non fermano: buttatevi avanti. — Non dubitare, magari sotto le ruote, mi butto, per fermarle. E poi: ho sulla licenza l’autorizzazione del signor Centurione a servirmi di automezzi. Altra pausa. L’autista innesta la radio: una canzone francese. La notte desolata ci è attorno. — Tua figlia quanti anni ha? — chiedo al milite, profittando della musica, che ci isola ancora più della notte, dell’andare. Il milite sorride: — Cinque anni. È un anno che non la vedo. — Che mestiere fai?
— Tagliaboschi. Non si lavora tutto l’anno; ma ora ci sono lavori in Puglia, e faccio il manovale. Si arrivano a guadagnare quindici lire al giorno; ero occupato in un cantiere lontano venti chilometri, che facevo in bicicletta. Occupiamo una casetta che ci costa 250 lire l’anno, bella, comoda: cucina e una stanza grande. Mia moglie è una donna che spacca il centesimo. Speriamo che non sia successo niente — conclude con un improvviso abbassamento di voce. Chiedo per distrarlo: — Sei qui dallo sbarco? — Con i primi, sono arrivato. Era di domenica, ed avevo portato al cinematografo mia figlia, e il figlio di Luigino. Torno a casa e trovo Luigino davanti alla porta, e gente in cucina. Che c’è, chiedo; niente, mi rispose Luigino, domani devi presentarti alla Legione. Fu richiamato anche un mio cugino. Non si sapeva che fosse: dove si andrà? Io ho fatto l’Africa e la Spagna, non potevo mancare a questa impresa. Era il 2 aprile; il 7 aprile sbarcavamo a Durazzo. Con gli albanesi ci stiamo bene: son sospettosi in principio, ma da quando hanno capito che noi li rispettiamo, che rispettiamo le loro case, il loro bestiame, le loro donne, allora si va d’accordo. Fanno doni: a noi sempre ci vogliono offrire tabacco, rachi, caffè! Si capisce che anche noi contraccambiamo. E qualche soldo si mette da parte: in sei mesi ho mandato 150 lire a casa: altre 150 ne porto con me. Ma i soldi, che importa? La salute ci vuole. Io, vedete, posso stare anche due giorni senza mangiare, non ci patisco: quando si hanno figli, è diverso, una creatura innocente non deve patire. A casa mia, da sei anni sposato, non ho fatto mancare mai nulla, grazie a Dio. Al bivio scende: — Auguri — gli gridiamo tutti. Preghiamo che la bimba di quel milite stia bene. Ha lasciato un vuoto nella macchina; un uomo, penso; veramente un uomo.
Continua…
[1] Tempo – Roma 21 dicembre 1939












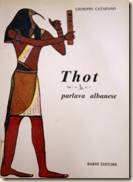

0 Commenti