L’assedio di Scutari (1912-1913)
L’assedio di Scutari (1912-1913)
Guerra, tradimenti e il destino di una città abbandonata
Elton A. Varfi
Basato su "L'Assedio di Scutari" di Gino Berri e fonti storiche verificate.
Le ragioni dell’assedio: il tramonto dell’Impero Ottomano e le ambizioni balcaniche
L’Impero Ottomano, un tempo incontrastato signore dei Balcani, all’inizio del XX secolo si trovava in una fase di profonda crisi. Da decenni, i territori europei dell’impero erano scossi da ribellioni nazionaliste e da continui conflitti, come le rivolte in Bosnia ed Erzegovina del 1875, la guerra serbo-bulgara del 1885 e l’insurrezione in Macedonia del 1903, che segnavano il progressivo disfacimento del dominio ottomano nella regione. La pressione esterna esercitata dalle potenze europee si accompagnava a un indebolimento interno dovuto a riforme tardive, corruzione diffusa e a una burocrazia inefficiente, elementi che rendevano il 'malato d’Europa' sempre più vulnerabile.
Nel 1912, la Serbia, il Montenegro, la Bulgaria e la Grecia, unite da un comune obiettivo di espansione territoriale, si coalizzarono contro l’Impero Ottomano, dando inizio alla Prima Guerra Balcanica. La campagna militare aveva un fine preciso: sottrarre agli ottomani gli ultimi territori europei ancora sotto il loro controllo e ridisegnare la mappa politica della regione, un obiettivo che sarebbe stato sancito dagli accordi di Londra del 1913, i quali definirono la spartizione dei territori e sancirono l’indipendenza dell’Albania. Nel cuore di questa contesa si trovava Scutari (Shkodër), una città strategica del nord dell’Albania, il cui possesso avrebbe garantito un vantaggio determinante per il controllo dell’Adriatico e delle vie di comunicazione interne.
Il Regno del Montenegro, guidato da Re Nicola I, ambiva a fare di Scutari un punto cardine della sua espansione territoriale, vedendola come un crocevia fondamentale per il controllo delle rotte commerciali adriatiche e un baluardo strategico contro le potenze vicine, nonché un obiettivo essenziale per affermare la sua influenza nell’area. La città, tuttavia, era strenuamente difesa da una guarnigione ottomana affiancata da volontari albanesi, determinati a resistere all’assedio. A capo delle operazioni difensive vi era il generale Hasan Riza Pascià, un comandante di grande esperienza, il cui impegno si rivelò cruciale nel prolungare la resistenza della città ben oltre le aspettative degli assedianti.
Ma all’interno delle mura di Scutari si muovevano anche altre forze, non sempre allineate con l’obiettivo della difesa a oltranza. Divergenze tra i comandanti ottomani e le milizie albanesi rendevano complessa la gestione della resistenza, mentre tensioni interne alimentavano sospetti e tradimenti che avrebbero inciso profondamente sul destino della città. Tra le figure più enigmatiche e controverse vi era Esad Pascià Toptani, ufficiale ottomano di origine albanese, la cui condotta si rivelò ambigua fin dai primi momenti dell’assedio. Uomo ambizioso e astuto, Toptani intratteneva rapporti con i montenegrini e, mentre la città resisteva con fatica, già ordiva piani per il proprio tornaconto personale. Il suo ruolo fu decisivo nel determinare la capitolazione della città e la successiva occupazione montenegrina, alterando profondamente le dinamiche politiche della regione e influenzando il futuro dell’indipendenza albanese.
Dentro l’assedio: un inferno di bombe, fame e disperazione
Il 28 ottobre 1912, l’assedio ebbe ufficialmente inizio. I montenegrini bloccarono le vie di accesso alla città e avviarono un bombardamento incessante. Nei primi giorni, l'artiglieria si concentrò sulle principali fortificazioni, cercando di aprire brecce nelle mura difensive. Con il passare delle settimane, il fuoco si fece sempre più intenso e indiscriminato, colpendo indiscriminatamente edifici civili e militari. A dicembre, con l'arrivo dell'inverno, l'assedio si inasprì ulteriormente: i colpi di cannone piovevano sulla città quasi senza sosta, riducendo interi quartieri in macerie e seminando il terrore tra la popolazione. Inizialmente, i colpi di cannone erano mirati agli avamposti militari e alle principali fortificazioni, ma con il passare del tempo, l’intensità dell’artiglieria si fece sempre più indiscriminata. Granate da 120 mm e proiettili di grosso calibro piovevano sulle case e sui mercati, distruggendo non solo le infrastrutture difensive, ma anche le abitazioni civili. I tetti crollavano, le strade si riempivano di detriti e il suono delle esplosioni divenne parte della vita quotidiana. Il fumo si alzava senza sosta, oscurando il cielo e rendendo l'aria irrespirabile. I sopravvissuti si spostavano tra le macerie con sguardi vacui, consapevoli che un altro attacco sarebbe presto arrivato.
Hasan Riza Pascià, il comandante della guarnigione ottomana, si dimostrò un leader abile e inflessibile. Sotto il suo comando, i difensori riuscirono a organizzare una resistenza ben coordinata, sfruttando le posizioni elevate e riorganizzando le truppe in settori strategici. I volontari albanesi si unirono alle truppe regolari, combattendo con determinazione per difendere la città. Ogni tentativo dei montenegrini di sfondare le difese si scontrava con la tenacia degli assediati. Gli attacchi notturni erano respinti con piogge di proiettili e contrattacchi mirati. Le strade di Scutari divennero un dedalo di barricate e trappole, mentre ogni edificio ancora in piedi veniva trasformato in un caposaldo difensivo. Anche le risorse disponibili venivano utilizzate in maniera ingegnosa: sacchi di sabbia riempiti con detriti per rafforzare le posizioni, bottiglie di vetro trasformate in armi improvvisate.
I turchi occupavano: Goloul (con una lunga trincea fino al lago), Bardanjoli, Renci, Tabaki, Tarabosch (l’estremo, dominato la città), Shiroka (sulla sponda del lago).
I montenegrini: Hani Trloki, Bilesi, Masulimi, Oblika (Bugajo), Murican, Zogai, Shiroka (a ducento metri sul fianco del Tarabosch), Tarabosch (la cresta, fino alle quote 661 e 570).
I serbi: Vulkatari, Asti, Kuisi, Busati, Melgusi.
Ma il vero nemico non era solo il Montenegro: era il tempo. L’inverno si avvicinava e con esso la morsa della fame e delle malattie. Le scorte di cibo si esaurirono rapidamente e la popolazione civile fu costretta a razionare ogni briciola. Il mercato nero divenne l’unica possibilità per ottenere qualcosa da mangiare, ma i prezzi erano proibitivi. Si racconta che persino la carne degli animali domestici divenne merce di scambio. Il gelo pungente si infiltrava nelle case distrutte e nei rifugi di fortuna, costringendo molti a bruciare mobili e oggetti personali per scaldarsi. Alcuni disperati si avventuravano oltre le mura in cerca di cibo, ma pochi facevano ritorno, caduti sotto il fuoco nemico o catturati dalle pattuglie montenegrine.
Le epidemie fecero il resto. Il tifo, la dissenteria e altre malattie contagiose si diffusero rapidamente tra la popolazione indebolita dalla fame e dal freddo. Senza acqua potabile e con le latrine stracolme, le condizioni igieniche precipitarono, favorendo il proliferare delle infezioni. Le strade erano disseminate di corpi che nessuno aveva la forza di seppellire, aumentando il rischio di ulteriori contagi. I pochi medici rimasti cercavano disperatamente di curare i malati con erbe medicinali e rimedi di fortuna, ma il numero dei decessi cresceva ogni giorno, lasciando la città sempre più vicina al collasso. Il tifo e la dissenteria si diffusero rapidamente a causa dell’acqua contaminata e della mancanza di condizioni igieniche adeguate. Gli ospedali da campo, allestiti in edifici danneggiati, erano stracolmi di feriti e malati. I medici, privi di medicinali, tentarono di improvvisare cure con infusi di erbe e rimedi popolari. Alcuni tentativi di inviare emissari oltre le linee nemiche per chiedere aiuti esterni fallirono miseramente: ogni messaggero catturato veniva giustiziato, e il blocco montenegrino rimase impenetrabile. Vi furono appelli rivolti alle potenze europee, in particolare all'Italia e all'Austria-Ungheria, ma le risposte furono tardive o inefficaci. I diplomatici ottomani cercarono di negoziare un corridoio umanitario, ma ogni tentativo venne ostacolato dall'intransigenza montenegrina e dalla situazione geopolitica più ampia. I corpi dei morti, che nessuno aveva più la forza di seppellire, iniziarono ad accumularsi nelle strade, creando una minaccia ancora maggiore per la salute pubblica. L’odore della morte e del fuoco impregnavano l’aria della città assediata.
Le donne di Scutari giocarono un ruolo fondamentale durante l’assedio. Oltre a prendersi cura dei feriti e dei malati, molte si unirono attivamente agli sforzi di difesa. Alcune portavano munizioni ai combattenti, altre scavavano trincee o aiutavano a rinforzare le barricate. Alcune donne più giovani si offrirono volontarie per trasportare messaggi segreti tra le linee difensive, sfidando il fuoco nemico per mantenere le comunicazioni operative. Vi erano anche madri che, nonostante la fame e il pericolo costante, cercavano disperatamente di sfamare i propri figli con i pochi alimenti rimasti, dimostrando una resilienza straordinaria in mezzo al caos.
Dentro le mura, Esad Pascià Toptani, ufficiale ottomano di origine albanese, aspettava il momento giusto per colpire. Intrattenendo segrete trattative con i montenegrini, cercava di minare la resistenza dall'interno, preparandosi a tradire la città per il proprio tornaconto personale. Esad Pascià Toptani, ufficiale ottomano di origine albanese, si mosse nell’ombra, intrattenendo segrete trattative con i montenegrini. Promettendo la resa della città in cambio del controllo su una futura amministrazione albanese, Toptani lavorò incessantemente per minare la leadership di Hasan Riza Pascià. La notte del 30 gennaio 1913, il comandante ottomano fu assassinato in circostanze sospette, lasciando la città priva della sua guida più capace. Senza la sua presenza, la difesa iniziò a vacillare, e la divisione interna tra le forze ottomane e i sostenitori di Toptani divenne sempre più evidente.
Le settimane passavano, e la tensione cresceva. Il cibo scarseggiava, i combattenti erano esausti, le munizioni diminuivano pericolosamente. La popolazione civile, stremata e disperata, iniziava a perdere la speranza. La città era al limite delle forze, eppure resisteva. Ma per quanto ancora avrebbe potuto farlo? Le mura reggevano, ma gli uomini al loro interno stavano cedendo. Il traditore aspettava, il nemico premeva, e il tempo stringeva. Gli ultimi giorni dell’assedio furono un vortice di caos e disperazione: le mura di Scutari, crivellate dai colpi, iniziavano a cedere in più punti, mentre i combattenti esausti tentavano di contenere le incursioni montenegrine. Gli ultimi rifornimenti di munizioni erano stati razionati fino all’estremo, e i soldati si trovavano costretti a combattere con armi spuntate e fucili scarichi. Nelle strade, il terrore era palpabile, tra le urla dei feriti e il lamento incessante dei civili in cerca di un rifugio sicuro. L’odore della polvere da sparo si mescolava a quello dei cadaveri in putrefazione. La resa sembrava ormai inevitabile, ma dentro le mura, mentre la città vacillava, Esad Pascià Toptani si preparava a compiere il tradimento che avrebbe definitivamente deciso il destino dell’assedio. Con un accordo segreto stretto con i montenegrini, attese il momento opportuno per prendere il controllo della città, consegnandola infine al nemico e assicurandosi un ruolo di primo piano nel nuovo assetto politico della regione. Il destino della città era ormai segnato, e gli eventi delle ore successive avrebbero scritto una delle pagine più drammatiche della storia balcanica.
Il tradimento: la caduta di Scutari e l’inganno di Esad Pascià
Il 30 gennaio 1913, Hasan Riza Pascià venne assassinato. La versione ufficiale parlò di un attacco nemico, ma molti sapevano la verità: era stato un omicidio orchestrato dall’interno, probabilmente su ordine di Esad Pascià Toptani. Alcuni documenti dell'epoca e testimonianze raccolte in seguito confermarono che Toptani aveva stretto accordi segreti con i montenegrini, e la rimozione di Hasan Riza Pascià era un passo necessario per portare avanti il suo piano di resa.
L’eliminazione del generale ottomano fu un colpo devastante per la resistenza della città. Hasan Riza era il cuore della difesa, il comandante che, con la sua strategia e il suo carisma, aveva mantenuto alto il morale delle truppe e della popolazione. Egli aveva organizzato una rete di postazioni difensive ben coordinate, sfruttando le alture circostanti per respingere gli assalti montenegrini. Fece fortificare le mura cittadine, utilizzando materiali di recupero per rinforzare le barricate. Inoltre, adottò tattiche di guerriglia urbana, impiegando piccoli gruppi di combattenti mobili per attaccare e ritirarsi rapidamente, logorando il nemico. Il suo piano prevedeva anche un uso mirato delle poche munizioni rimaste, riservando il fuoco dell'artiglieria ai punti strategici di maggiore pressione nemica. Senza di lui, la catena di comando si indebolì rapidamente e le speranze di una resistenza prolungata iniziarono a sgretolarsi.
Dopo la morte di Hasan Riza, il panico si diffuse tra i difensori della città. Alcuni ufficiali cercarono di prendere in mano la situazione, ma l’influenza di Esad Pascià era ormai troppo forte. Egli manovrava con abilità, promettendo ai comandanti più titubanti che la resa sarebbe stata l’unico modo per salvare Scutari dalla distruzione totale. Nel frattempo, intratteneva trattative segrete con le autorità montenegrine, offrendo loro il controllo della città in cambio di protezione e garanzie sul proprio futuro politico. L’accordo prevedeva che Toptani potesse lasciare Scutari con onori militari, mantenendo il comando di una propria milizia e ricevendo il sostegno per consolidare la sua posizione politica in Albania. In cambio, si impegnava a non opporre resistenza all'occupazione montenegrina e a persuadere la popolazione e i restanti difensori ad accettare pacificamente la resa. I soldati, sempre più sfiduciati, iniziavano a dubitare dell’efficacia della resistenza, mentre le scorte di munizioni e viveri si riducevano drasticamente.
Il 23 aprile 1913, dopo sei mesi di resistenza eroica, Esad Pascià consegnò Scutari ai montenegrini senza combattere. Il patto segreto garantì a Toptani di poter lasciare la città con onore, mantenendo il comando di una milizia personale. Per giustificare la sua decisione, egli diffuse la versione secondo cui la resa era necessaria per evitare ulteriori sofferenze alla popolazione. Ma per chi aveva resistito tra fame e bombardamenti, la verità era evidente: era stato un tradimento orchestrato per il suo tornaconto personale.
Quando i montenegrini entrarono in città, trovarono una Scutari devastata. I palazzi ridotti in macerie, le strade coperte di detriti e cadaveri, l’odore della morte ancora nell’aria. La popolazione, che aveva sopportato mesi di privazioni e terrore, si vide abbandonata. La promessa di sicurezza si rivelò presto una menzogna: i vincitori saccheggiarono i quartieri ancora intatti, mentre i soldati si appropriarono delle poche risorse rimaste. Nelle case abbandonate, i montenegrini rovesciarono mobili e bruciarono ciò che non potevano portare via. I negozi furono svuotati, e i loro proprietari ridotti in miseria. La cattedrale venne violata, e persino gli oggetti sacri furono trafugati. Nei mercati deserti, le ultime scorte di grano e farina furono sequestrate, lasciando la popolazione senza alcun mezzo di sussistenza.
Scene di disperazione si susseguirono per giorni, con famiglie intere in lacrime mentre assistevano impotenti alla distruzione della loro città. Gli abitanti di Scutari, esausti e affamati, non avevano più nessuno a cui rivolgersi. Alcuni tentarono la fuga, cercando riparo nei villaggi circostanti o tentando di attraversare il lago di Scutari per mettersi in salvo. Altri organizzarono forme di resistenza locale, opponendosi ai saccheggi e cercando di proteggere ciò che restava delle loro case. Tuttavia, senza un coordinamento militare e privi di armi adeguate, ogni tentativo di ribellione fu rapidamente soffocato. Molti furono catturati e giustiziati come esempio per scoraggiare ulteriori insurrezioni, mentre le famiglie sfollate vagavano alla ricerca di aiuto, spesso senza trovare nessuna speranza di salvezza. Donne e bambini vagavano per le strade in cerca di cibo e protezione, mentre i sopravvissuti ai combattimenti cercavano rifugio tra le macerie delle loro case distrutte.
L’occupazione montenegrina non durò a lungo. Le pressioni internazionali, soprattutto da parte dell’Austria-Ungheria e dell’Italia, imposero il ritiro delle truppe montenegrine. Le potenze europee non volevano permettere che il Montenegro rafforzasse troppo la propria posizione nei Balcani e temevano ripercussioni diplomatiche. L'Austria-Ungheria, in particolare, vedeva l'espansione montenegrina come una minaccia al proprio controllo sulla regione e fece pressioni per un intervento internazionale attraverso minacce militari e manovre diplomatiche. L'ultimatum inviato a Belgrado e Cettigne fu accompagnato dal rafforzamento delle truppe lungo il confine con il Montenegro, segnalando la determinazione viennese a impedire l'annessione definitiva di Scutari. Parallelamente, l'Austria-Ungheria si mosse nelle sedi diplomatiche europee, convincendo le altre potenze a sostenere un'azione internazionale per costringere il Montenegro al ritiro. L'Italia, temendo un riequilibrio strategico sfavorevole nell'Adriatico, si unì agli sforzi diplomatici per forzare un ritiro. Dopo intense negoziazioni tra le potenze, il 21 maggio 1913 il Montenegro accettò di evacuare Scutari in cambio del riconoscimento delle sue conquiste territoriali in altre aree balcaniche. La città fu quindi posta sotto il controllo di una missione internazionale composta da forze austriache, italiane e britanniche. Questa missione aveva il compito di garantire la stabilità della regione e impedire ulteriori conflitti, ma la sua autorità era limitata e incontrò numerose difficoltà nel riportare l'ordine. L'amministrazione internazionale cercò di distribuire aiuti alla popolazione, ormai allo stremo, e di ristabilire le infrastrutture minime necessarie alla sopravvivenza della città. Tuttavia, la tensione rimase alta, con sporadici scontri tra fazioni locali e un diffuso sentimento di sfiducia verso le forze straniere, percepite da molti come un'occupazione mascherata. Tuttavia, per Scutari nulla sarebbe stato come prima. L’abbandono improvviso da parte di Esad Pascià lasciò un vuoto di potere che portò a disordini e tensioni interne. La popolazione, già stremata, dovette affrontare una nuova incertezza politica, con bande armate che cercavano di imporsi nel caos post-bellico.
Il tradimento di Esad Pascià aveva segnato un punto di svolta nella storia albanese. Le sue azioni furono viste da molti come un atto di opportunismo politico, un sacrificio della città in cambio di ambizioni personali. La popolazione di Scutari, invece, pagò il prezzo più alto: dopo mesi di resistenza eroica, fu lasciata senza protezione, in balia delle forze occupanti e delle conseguenze politiche della resa. Mentre Esad Pascià si ritagliava un posto sulla scena politica albanese, Scutari leccava le proprie ferite, portando per sempre le cicatrici del tradimento.
Dopo la sua partenza, la città visse un periodo di instabilità, con il timore che nuovi conflitti potessero scoppiare da un momento all’altro. L’amministrazione internazionale, pur tentando di stabilizzare la situazione, faticò a ristabilire l’ordine e a garantire la sicurezza ai cittadini. Nel frattempo, Esad Pascià si adoperò per consolidare il suo potere, cercando l’appoggio delle potenze europee per legittimare la sua leadership in Albania. Tuttavia, il suo nome rimase macchiato dal sospetto e dalla diffidenza, e la sua ascesa politica fu accompagnata da accuse di corruzione e doppiogiochismo. La popolazione di Scutari, invece, si trovò a dover ricostruire una città devastata, con risorse limitate e incertezza sul futuro, mentre il tradimento di Toptani restava un ricordo indelebile nella memoria collettiva. La sua figura rimase una delle più controverse nella storia dell’Albania, con alcuni che lo consideravano un abile stratega e altri che non gli avrebbero mai perdonato la resa della città. La memoria del suo gesto avrebbe pesato per generazioni, un monito delle conseguenze dell’ambizione personale sopra l’interesse collettivo. La resa di Scutari non fu solo un evento militare, ma un episodio che segnò profondamente la politica e la società albanese. Il tradimento di Esad Pascià alimentò il risentimento tra le fazioni nazionaliste e contribuì a plasmare la coscienza collettiva del popolo albanese nei decenni successivi. L’episodio rafforzò l’idea di una necessità impellente di autodeterminazione e unità nazionale, influenzando direttamente il movimento per l’indipendenza albanese. Negli anni successivi, figure politiche e militari citarono la resa di Scutari come monito contro il rischio di interferenze straniere e tradimenti interni. Durante la creazione del governo provvisorio albanese e i negoziati per il riconoscimento dell’indipendenza nel 1913, il ricordo del comportamento di Esad Pascià spinse molti leader nazionalisti a rafforzare la propria opposizione a qualsiasi compromesso che potesse minare la sovranità albanese. Anche negli anni successivi, fino all’epoca della Seconda guerra mondiale, il nome di Toptani fu usato dai movimenti nazionalisti per denunciare gli albanesi accusati di collaborare con potenze straniere a scapito della nazione. L’episodio fu usato come esempio per dimostrare i pericoli dell’avidità politica e dell’interferenza straniera, influenzando la narrativa storica e il processo di costruzione dell’identità nazionale. Alcuni storici, tra cui Gino Berri e Eqrem Vlora, hanno analizzato il ruolo di Esad Pascià Toptani, sottolineando come il suo tradimento sia stato percepito come un simbolo di opportunismo politico. Documenti diplomatici dell'epoca e testimonianze raccolte negli anni successivi confermano il forte impatto che la caduta di Scutari ebbe sulla percezione dell'indipendenza albanese, alimentando il dibattito sulle fragilità interne che avrebbero caratterizzato il paese nei decenni successivi. Ancora oggi, il suo nome evoca divisioni e riflessioni sulla fragilità dell’indipendenza e sulla necessità di un’unità nazionale autentica.
La ritirata ingloriosa: il fallimento montenegrino e il destino di Scutari
Il Montenegro si illuse di aver vinto. Quando le truppe montenegrine entrarono in Scutari, furono accolte con celebrazioni ufficiali organizzate dal comando militare. Le campane delle chiese risuonarono in segno di vittoria e furono issate bandiere lungo le strade principali. I giornali di Cettigne esaltarono la conquista come un trionfo storico, destinato a rafforzare il ruolo del Montenegro nei Balcani. Tuttavia, dietro questa euforia, la realtà della situazione internazionale stava rapidamente ribaltando il destino della città appena occupata. Le grandi potenze europee non volevano che la città finisse sotto il controllo montenegrino. L’Italia e l’Austria-Ungheria, in particolare, temevano che ciò avrebbe alterato gli equilibri nei Balcani. Il governo italiano, preoccupato per l’influenza slava nell’Adriatico, e l’Impero austro-ungarico, deciso a impedire che il Montenegro accrescesse la propria sfera d’influenza, fecero pressioni sulle altre potenze per agire rapidamente. Anche la Serbia, nonostante fosse alleata del Montenegro, si trovò in una posizione difficile, poiché non voleva compromettere i rapporti con le grandi potenze europee. Francia e Gran Bretagna osservavano attentamente la situazione, cercando di evitare un'escalation del conflitto, ma non intervennero direttamente.
Il 10 aprile 1913, l’Europa impose un blocco navale al Montenegro. Navi da guerra italiane e austro-ungariche pattugliarono le coste montenegrine, impedendo l’arrivo di rifornimenti. Il porto di Antivari fu completamente bloccato, isolando ulteriormente il regno. Isolato diplomaticamente e militarmente, il piccolo regno si trovò sotto una crescente pressione. Re Nicola I tentò di resistere, inviando disperati appelli alla Russia, la storica protettrice degli slavi balcanici, ma senza successo. La Russia, pur simpatizzando per il Montenegro, non era disposta a rischiare una crisi con le potenze occidentali per una questione territoriale secondaria. Le condizioni delle truppe montenegrine peggioravano di giorno in giorno: la mancanza di rifornimenti e il morale a terra rendevano impossibile mantenere il controllo su Scutari.
Il 14 maggio 1913, Re Nicola I fu costretto a ritirare le sue truppe da Scutari in seguito agli accordi diplomatici imposti dalle grandi potenze europee. La pressione dell'Austria-Ungheria e dell'Italia, formalizzata durante i colloqui internazionali a Londra, obbligò il sovrano montenegrino ad abbandonare le sue pretese sulla città. Il ritiro fu ufficialmente sancito da un ultimatum, che prevedeva l'evacuazione completa delle forze montenegrine sotto la supervisione di osservatori internazionali. Re Nicola I, nonostante le sue rimostranze, dovette accettare l'ordine per evitare un conflitto diretto con le potenze occidentali. La ritirata fu caotica e umiliante. I soldati montenegrini, esausti dopo mesi di assedio, lasciarono la città senza alcun riconoscimento ufficiale. Le loro speranze di ottenere Scutari come trofeo di guerra si infransero contro la dura realtà della diplomazia internazionale. L'ordine di evacuazione fu dato improvvisamente e molte unità si ritirarono in disordine, lasciando sul campo armi ed equipaggiamenti. L’evacuazione avvenne sotto la supervisione delle forze internazionali, e le truppe montenegrine dovettero abbandonare la città in fretta, senza poter nemmeno celebrare la loro temporanea conquista. La popolazione locale osservò la loro ritirata con un misto di sollievo e amarezza, consapevole che la sofferenza non era ancora finita.
Dopo sei mesi di resistenza, il popolo di Scutari aveva perso tutto. Si stima che oltre 10.000 persone, tra civili e combattenti, abbiano perso la vita a causa dei combattimenti, della fame e delle malattie. Più della metà delle abitazioni cittadine risultava distrutta o gravemente danneggiata, e interi quartieri furono rasi al suolo dai bombardamenti incessanti. Le infrastrutture essenziali, come ponti e reti idriche, erano state compromesse, rendendo la sopravvivenza ancora più difficile per chi era rimasto in città. Morte, fame e distruzione erano il lascito dell’assedio. I quartieri un tempo vivaci erano ridotti in rovine, e il commercio cittadino era paralizzato. Le condizioni igienico-sanitarie erano disastrose: l’acqua potabile scarseggiava, le malattie si diffondevano rapidamente, e la popolazione sopravvissuta era decimata dalla carestia. Molte famiglie abbandonarono la città, cercando rifugio nei villaggi circostanti, mentre altre, troppo povere per fuggire, dovettero adattarsi a vivere tra le macerie. La situazione era resa ancora più drammatica dalla mancanza di aiuti immediati, poiché le potenze europee, pur avendo imposto il ritiro montenegrino, non avevano predisposto alcun piano di emergenza per la popolazione civile. Solo dopo settimane arrivarono le prime missioni umanitarie, organizzate principalmente dalla Croce Rossa Internazionale e da alcune associazioni benefiche italiane e austro-ungariche. Tuttavia, gli aiuti furono limitati e insufficienti per alleviare la sofferenza della città. Le poche scorte di cibo e medicinali non bastavano a coprire le esigenze della popolazione, e la distribuzione degli aiuti risultò caotica a causa dell’assenza di un’amministrazione locale efficace. Molti dei sopravvissuti, indeboliti dalla fame e dalle malattie, non riuscirono a ricevere le cure necessarie, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria.
Esad Pascià, il grande traditore, sfuggì alle conseguenze immediate. Dopo aver lasciato Scutari, si stabilì a Durazzo, dove tentò di consolidare il proprio potere con l’appoggio delle potenze occidentali. Per alcuni anni, riuscì a mantenere un ruolo politico di rilievo, presentandosi come il garante della stabilità in Albania. Tuttavia, la sua fama di opportunista e traditore non lo abbandonò mai. I suoi avversari politici lo accusavano apertamente di aver venduto Scutari per il proprio tornaconto, mentre lui cercava di ricostruire la propria influenza attraverso alleanze con i leader locali e le potenze straniere. La sua posizione divenne sempre più precaria con il consolidamento dello Stato albanese, e la sua figura fu sempre più associata al tradimento.
Nel 1920, mentre si trovava a Parigi per cercare sostegno politico e finanziario, fu assassinato da Avni Rustemi, un giovane nazionalista albanese deciso a vendicare il tradimento di Scutari. La sua morte fu accolta con reazioni contrastanti: per alcuni era la giusta punizione per un uomo che aveva venduto la sua patria, per altri fu l’eliminazione di un politico scaltro che, nonostante i suoi metodi discutibili, aveva cercato di garantire un equilibrio in un’Albania frammentata. Il suo nome rimase per sempre legato all’episodio di Scutari, simbolo di tradimento e divisione, continuando a suscitare dibattiti tra storici e politici.
Un’eredità di sangue e memoria
L’assedio di Scutari non fu solo un evento bellico, ma una tragedia umana che segnò per sempre il destino della città e del suo popolo. Si stima che oltre 10.000 persone, tra civili e combattenti, abbiano perso la vita a causa dei combattimenti, della fame e delle malattie. Le cronache dell'epoca e i documenti storici confermano l'entità della devastazione subita dalla popolazione. Case distrutte, famiglie annientate, una comunità ridotta allo stremo: Scutari non fu semplicemente conquistata, fu abbandonata da coloro che avrebbero dovuto difenderla. Ogni strada della città portava i segni del lungo assedio, e ogni famiglia aveva perso qualcuno nel caos della guerra. Il sacrificio di tanti fu reso vano da un tradimento che lasciò cicatrici più profonde di quelle inflitte dalle bombe. Le speranze di resistenza furono calpestate dalla meschinità politica, trasformando la città in una ferita aperta nella storia albanese.
Scutari non fu sconfitta dal nemico, ma venduta dall’interno. Le mura non cedettero sotto i colpi dell’artiglieria montenegrina, ma sotto il peso della corruzione, dell’opportunismo e dell’avidità politica. Gli uomini che avrebbero dovuto proteggere la città preferirono garantirsi un futuro personale piuttosto che combattere fino all’ultimo respiro. Esad Pascià Toptani, il simbolo di questo tradimento, orchestrò la resa mentre i cittadini morivano di stenti nelle strade. La sua decisione non fu un atto isolato, ma il culmine di una serie di manovre segrete che avevano preparato il terreno per la capitolazione. Il prezzo di questa resa non si misurò solo in vite umane, ma nella dignità perduta di un popolo costretto a piegarsi non per la forza del nemico, ma per la slealtà di chi si trovava al suo fianco. La consegna della città non fu solo una questione militare, ma politica: un gioco di potere che vide Scutari diventare merce di scambio in una partita più grande, decisa lontano dai suoi confini. Le principali potenze europee, tra cui Austria-Ungheria e Italia, manovrarono dietro le quinte per impedire che il Montenegro rafforzasse la propria posizione nei Balcani. Il Regno Unito e la Francia, pur osservando con attenzione, preferirono non interferire direttamente, lasciando che la diplomazia e gli interessi strategici determinassero il destino della città. Alla fine, furono gli equilibri internazionali e non il valore militare a decidere il futuro di Scutari.
L’eco del tradimento risuonò ben oltre la città stessa. La popolazione, segnata dalla fame e dalla disperazione, non aveva altra scelta che adattarsi a un destino imposto dall’alto. Alcuni fuggirono, cercando rifugio nei villaggi circostanti, mentre altri rimasero, costretti a ricostruire sulle macerie di un passato violato. I racconti di quel periodo si tramandarono di generazione in generazione, trasformandosi in una memoria collettiva di dolore e rabbia. Questo episodio fu evocato in diverse opere letterarie e storiche, come negli scritti di Eqrem Vlora e nelle cronache di Gino Berri, che ne descrissero le conseguenze con precisione e pathos. Ancora oggi, commemorazioni e studi storici richiamano il sacrificio di Scutari, rendendo questo evento un punto di riferimento nella costruzione dell’identità nazionale albanese. Le ferite della resa di Scutari non si rimarginarono mai del tutto, e ancora oggi l’episodio rappresenta un simbolo delle divisioni che possono lacerare una nazione dall’interno.
L’assedio di Scutari rimane un monito su come la guerra non sia solo fatta di battaglie, ma anche di intrighi, tradimenti e sofferenza. Gli eventi di Scutari sono ricordati non solo per il coraggio dei suoi abitanti, ma anche per il senso di amarezza lasciato dall’epilogo. Il nome della città è diventato un simbolo della resistenza, ma anche dell’ingiustizia subita. Ogni generazione che studia la storia dell’Albania si imbatte in questo episodio, trovandovi una lezione universale: nessuna fortezza è davvero inespugnabile se il nemico si trova all’interno delle sue mura. Un esempio simile si può ritrovare nella caduta di Costantinopoli nel 1453, dove il tradimento interno e le divisioni politiche indebolirono la difesa della città, facilitandone la conquista da parte degli Ottomani. Anche in epoche più recenti, episodi di instabilità interna hanno spesso giocato un ruolo decisivo nella caduta di regimi o nella perdita di territori. L'assedio di Scutari è quindi un monito eterno, che riecheggia attraverso la storia, ricordando che le minacce più pericolose non sempre provengono dall’esterno, ma spesso nascono da dentro.
La vicenda di Scutari divenne un punto di riferimento per il futuro della nazione albanese. La diffidenza verso le potenze straniere e il timore del tradimento interno influenzarono profondamente la politica e la mentalità del popolo albanese nei decenni successivi. Il tradimento di Scutari è entrato nella memoria collettiva come un esempio di come la politica possa essere più spietata della guerra stessa, lasciando un’eredità di dolore e riflessione per i posteri. Tuttavia, pur essendo un evento di grande rilevanza storica, oggi non è frequentemente menzionato nel dibattito pubblico, se non da storici, scrittori e studiosi della storia balcanica. Il suo ricordo è presente soprattutto nelle opere accademiche e nelle analisi storiche, dove viene citato come un esempio delle complesse dinamiche geopolitiche che hanno caratterizzato la regione. Sebbene non sia un riferimento costante nella politica contemporanea, l’assedio di Scutari rappresenta ancora un punto di riflessione per chi studia il passato dell’Albania e il suo percorso verso l’indipendenza e la stabilità.
Fonti
Gino Berri, L’Assedio di Scutari (1912-1913).
Enciclopedia Britannica, First Balkan War.
Wikipedia, Siege of Scutari (1912–1913).
Wikipedia, Hasan Riza Pasha.
Wikipedia, Essad Pasha Toptani.
[1] Le foto presenti in questo testo sono tratte dal libro di G. Berri, pubblicato nel 1913. Nonostante la qualità non sia ottimale, queste immagini rappresentano preziose testimonianze visive, utili per comprendere meglio la storia narrata.
















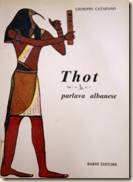

0 Commenti