Deti i gjerë e i pa anë – Il mare al centro del mito e della memoria albanese
Elton A. Varfi
|
Deti
i gjerë e i pa anë,
|
Il
mare vasto e senza confine,
|
|
që
mban brenda gjithësinë,
|
che
in sé racchiude ogni origine,
|
|
nga
ty kemi dalë,
|
da
te veniamo, flusso divino,
|
|
dhe
prapë tek ty do të vijmë.
|
a
te torniamo, nostro destino.
|
In questa strofa anonima, trasmessa oralmente per generazioni, si condensa una concezione mistica del mondo. Non è solo una poesia, è un frammento di cosmologia. Il mare non è descritto, è evocato come principio e fine, come ventre e tomba, come grembo e dissoluzione. La sua vastità senza confini non è semplice constatazione geografica, ma allusione al mistero. L’assenza di limiti diventa simbolo di ciò che non può essere misurato, definito, trattenuto.
Nel dire che il mare “mban brenda gjithësinë”, la voce popolare rivela una verità che attraversa millenni di cultura: tutto è contenuto nell’acqua, tutto ha origine nell’acqua, tutto ritorna a essa. Questa immagine non è lontana dalla Genesi, dove lo Spirito aleggia sulle acque primordiali. Né è distante dal Corano, che afferma: “Noi abbiamo tratto ogni essere vivente dall’acqua.” È sorprendente che un pensiero tanto profondo sia sopravvissuto nella semplicità di una cultura orale, senza scrittura, senza teologia, eppure capace di conservare intatto il nucleo dell’origine.
La Creazione della Luce – Immagine ispirata al primo verso della Genesi: “Sia la luce”.
“Nga ty kemi dalë” è un verso che unisce scienza e spiritualità. Siamo usciti dal mare: lo dice la biologia, ma anche il mito. È una dichiarazione che precede ogni dottrina, che esiste da prima delle religioni, e che sopravvive in un verso che il popolo ha cantato senza saperne spiegare il significato, ma custodendolo con fedeltà.
“Dhe prapë tek ty do të vijmë” chiude il ciclo. Torneremo. Non c’è separazione definitiva. Non c’è fuga. C’è un ritorno, inevitabile e naturale. Il mare ci richiama, ci accoglie, ci riassorbe. In questo ritorno non c’è condanna, c’è pace. La stessa pace che i mistici cercano nell’unione con l’Assoluto, nel dissolversi nell’Uno.
Quattro versi. Nessun nome. Nessuna pretesa. Eppure, c’è tutto. C’è la memoria arcaica dell’uomo. C’è l’incontro tra natura e spirito. C’è la consapevolezza che l’acqua è madre, giudice e rifugio. C’è l’eco delle Scritture, senza averle lette. E c’è una saggezza che solo chi ascolta il silenzio del mare può capire davvero.
Questi versi, nati dalla voce collettiva del popolo albanese, sembrano sussurrare un sapere remoto, arcaico, ma straordinariamente vicino alle parole con cui inizia la Bibbia. La Genesi, infatti, apre il racconto della creazione con una scena dominata dalle acque:
“La terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque.” (Genesi 1:2)
Non è una semplice coincidenza. Prima della luce, prima della terra, prima della parola, c’erano le acque. Non è un dettaglio trascurabile o una suggestione poetica: è una visione ontologica dell’esistenza. L’acqua, nella Bibbia come nella poesia popolare albanese, non è un elemento tra gli altri: è l’inizio, il grembo del possibile, la culla del mondo. È lì che si muove lo Spirito, è lì che si accende la scintilla della creazione. L’ordine nasce da quel caos liquido, da quel fluire primordiale che precede ogni forma.
La strofa albanese, pur priva di riferimenti religiosi espliciti, riflette con impressionante naturalezza la stessa visione. Il mare che “mantiene in sé l’intero universo” (që mban brenda gjithë gjithësinë) è una forma poetica dell’abisso biblico: profondo, oscuro, sacro. L’assenza di un Dio nominato non significa assenza del sacro, ma anzi, conferisce al mare una divinità implicita, impersonale e universale. Non c’è bisogno di invocare un nome per percepire la sacralità di ciò che accoglie, contiene e restituisce la vita. Il mare, come archetipo, si sostituisce alla divinità antropomorfa: non parla, non giudica, non crea nel senso umano del termine, ma accoglie, custodisce, trasforma.
Il terzo e quarto verso – nga ty kemi dalë / dhe prapë tek ty do të vijmë – richiamano un’altra fondamentale idea biblica: il ritorno. “Polvere tu sei e in polvere ritornerai” (Genesi 3:19), dice Dio all’uomo, segnando il destino circolare dell’essere umano. Qui, però, la polvere è sostituita dal mare. È una variante potente: non una secchezza, ma un’umidità originaria; non un dissolvimento, ma un assorbimento. Il ritorno al mare non è perdita, ma reintegrazione. È il riassorbirsi nel tutto da cui si è venuti. Una fine che non è sparizione, ma reincontro. Questo concetto, così poeticamente espresso, è in sé una sintesi di religione e filosofia, di spiritualità e biologia.
Ma la Bibbia è solo uno dei testi sacri che celebrano l’acqua come principio e destino. Nell’Islam, l’acqua è fonte di ogni cosa viva: “Abbiamo tratto da acqua ogni essere vivente” (Corano 21:30). È la sostanza prima, l’origine della vita biologica e dell’ordine cosmico. Nell’induismo, le acque primordiali precedono la nascita del cosmo. Esse fluttuano nel nulla prima che Brahma emerga e dia forma al mondo. Nell’antico Egitto, il dio Nun rappresenta l’oceano primigenio da cui nascono gli dei e l’universo. Anche nella filosofia presocratica, Talete afferma che tutto ha origine dall’acqua. Tutte queste visioni convergono su un punto essenziale: prima di tutto c’era l’acqua, e tutto da lì proviene.
La risonanza di questo pensiero con la strofa albanese è impressionante. Quattro versi anonimi, privi di dottrina, eppure carichi di una verità universale. Non c’è dogma, non c’è libro sacro, ma una intuizione profondissima: la vita viene dal mare, e al mare ritorna. In questa visione, il mare non è più uno spazio geografico, ma un concetto cosmico. Non è solo mare come lo intendiamo nel linguaggio comune, ma simbolo dell’origine e della fine, della madre e della tomba, del principio e del compimento
Ciò che rende la strofa albanese unica è proprio il fatto che essa non proviene da una dottrina, ma da una tradizione orale. Non è il frutto di una teologia sistematica, ma di una cultura che ha saputo leggere il mondo senza libri, intuire la verità osservando la natura, distillare il senso del divino nei versi brevi della memoria collettiva. È questa la forza della cultura popolare: dire tutto con poco, custodire il mistero in forma accessibile, ma non per questo meno profonda.
In questo senso, il mare non è solo il contenuto della poesia: è il suo metodo. Come il mare raccoglie e mescola, così la voce del popolo assorbe elementi sparsi, li sedimenta, e restituisce una verità più grande. È un sapere che non distingue tra scienza e mito, tra religione e osservazione empirica, tra sacro e profano. È un sapere fluido, come l’acqua stessa.
Nella cultura contadina albanese, i testi sacri sono stati spesso trasmessi per via orale, reinterpretati, mescolati a credenze precristiane o islamiche, eppure la loro eco è rimasta. Non come dogma, ma come visione. Non come legge, ma come percezione poetica. Le verità ultime non venivano scritte, ma cantate. Le parole, prima ancora di essere fissate sulla carta, vivevano sulle labbra della gente, si trasmettevano come semi da una generazione all’altra, si modificavano appena, ma mai nel cuore del loro significato.
Così, la strofa sul mare diventa una sorta di Genesi non scritta, parallela, popolare, ugualmente sacra. Ci ricorda che esistono più modi per raccontare l’inizio, e che le parole dette sotto voce attorno a un fuoco, o sussurrate in una canzone, possono valere quanto un versetto inciso su pietra. Quella che la Bibbia racconta come l’origine dell’universo, i contadini albanesi la affidavano a un’immagine: il mare che ci genera e che ci accoglie al termine del cammino. Non serviva la pagina di un libro. Bastava la voce, la memoria, l’esperienza quotidiana con la terra, il cielo e l’acqua.
Nga ty kemi dalë
dhe prapë tek ty do të vijmë
 Canto polifonico del Sud Albania – Un gruppo di uomini albanesi intona un brano della tradizione polifonica. L’oralità diventa voce collettiva, memoria incarnata, testimone di una saggezza ancestrale che attraversa le generazioni senza mai spegnersi
Canto polifonico del Sud Albania – Un gruppo di uomini albanesi intona un brano della tradizione polifonica. L’oralità diventa voce collettiva, memoria incarnata, testimone di una saggezza ancestrale che attraversa le generazioni senza mai spegnersi
Questi due versi, che costituiscono la seconda metà della strofa, contengono una delle intuizioni più profonde mai espresse dalla poesia popolare: che la vita umana abbia avuto origine dal mare. Per un popolo contadino, montanaro, legato alla terra e alle sue stagioni, un’affermazione del genere non è affatto scontata. Anzi, è sorprendente. È la prova che l’osservazione istintiva, l’intelligenza orale e la riflessione simbolica possono giungere alle stesse verità che la scienza ha dimostrato solo di recente. È un ponte tra il mito e il microscopio, tra il canto e il laboratorio.
Oggi sappiamo, con ragionevole certezza, che la vita è comparsa sulla Terra circa 3,5 miliardi di anni fa, nei mari primordiali. In quelle acque dense e minerali si formarono le prime molecole organiche, poi le prime cellule, poi organismi sempre più complessi. E da lì, in un lunghissimo percorso evolutivo, nacquero i pesci, gli anfibi, i rettili, i mammiferi, gli esseri umani. L’oceano non è stato solo il nostro grembo: è stato la nostra prima casa, il primo respiro, la prima culla. L’acqua, ancora oggi, scorre nelle nostre vene.
È dunque un fatto accertato che siamo nati dall’acqua, che il mare è la nostra origine biologica. Ma nella poesia popolare albanese, tutto questo viene detto senza prove, senza esperimenti, senza linguaggio tecnico. Viene detto con naturalezza, con quella forza semplice che appartiene solo a chi parla in sintonia con la natura: nga ty kemi dalë – da te siamo usciti. Non c’è esitazione, non c’è bisogno di spiegazioni: è un dato di fatto che vive nel corpo e nello spirito, nel sangue e nel canto.
Come facevano gli antichi a intuirlo? Forse osservando il mondo. Tutto ciò che vive ha bisogno d’acqua. Gli animali, le piante, gli uomini: niente sopravvive senz’acqua. I neonati crescono nel grembo materno immersi in liquido. Le donne rompono le acque prima di partorire. Il sangue ricorda, nella sua salinità, l’acqua marina. E allora forse, senza saperlo, i nostri antenati collegarono l’esperienza della nascita a quella del mare. Non ci fu bisogno di filosofia astratta: bastava la concretezza dell’esperienza, bastava osservare ciò che avviene nel corpo e nella terra.
Se il ritorno alla terra – alla polvere – è la visione dominante nelle culture agricole, qui si apre una variante inaspettata: non ceneri, ma onde. Non secchezza, ma fluidità. La morte non come fine, ma come ritorno all’elemento primordiale. La dissoluzione nel mare non è perdita, ma ricongiungimento. Questo è un pensiero che consola, che libera, che abbraccia. Una forma di religiosità naturale, priva di dogmi, fatta di intuizioni profonde che ci ricordano chi siamo e da dove veniamo. E ci suggeriscono, in silenzio, dove torneremo.
Ma forse c'è di più. La cultura orale non distingue nettamente tra realtà e simbolo. Dire che veniamo dal mare non è solo una dichiarazione fisica, ma un atto di riconoscimento simbolico: il mare è grembo, è madre, è origine. È ciò da cui siamo nati, anche spiritualmente. È da lì che abbiamo ricevuto il primo respiro, anche se non lo ricordiamo.
E poi c'è l'aspetto del ritorno. Se da lì veniamo, è lì che torneremo. Come gocce che si staccano e poi ricadono. Questa visione circolare della vita non è scientifica, ma poetica, eppure le due si incontrano. La materia del nostro corpo – l'acqua, i sali, gli atomi – dopo la morte ritorna all'ambiente, al ciclo della natura, e spesso finisce di nuovo… nel mare.
C'è un'antica sapienza nel riconoscere che non siamo padroni dell'universo, ma suoi figli, e che il nostro destino non è l'ascesa, ma il ritorno. Il ritorno alla fonte, alla madre, al liquido da cui tutto è partito. In questo senso, la poesia popolare albanese si fa quasi filosofia dell'equilibrio naturale. Non predica, non spiega, non argomenta: afferma, con dolcezza e potenza.
E affermando che veniamo dal mare, anticipa la scienza, senza volerla sfidare, ma semplicemente perché è guidata da un'altra forma di sapere: quello che nasce dall'osservazione lenta, dalla memoria collettiva, dall'intimità con la terra e con l'acqua.
Deti i gjerë e i pa anë,
që mban brenda gjithësinë,
nga ty kemi dalë
dhe prapë tek ty do të vijmë.
Questa strofa non nasce in un vuoto. È figlia di un mondo antico, in cui il mito non era un racconto lontano, ma parte viva della realtà quotidiana. Nei Balcani, l'acqua è sempre stata qualcosa di più di un elemento naturale: è un varco, un confine, un essere vivente. Ogni fiume aveva un nome, ogni sorgente una leggenda, ogni lago un segreto. E il mare – vasto, pericoloso, irraggiungibile – era il più misterioso di tutti.
Nella tradizione balcanica, l'acqua è sacra. È legata alla fertilità, alla morte, alla rinascita. È l'elemento che connette il mondo dei vivi e quello dei morti. Le abluzioni, le offerte gettate nei fiumi, le preghiere rivolte a sorgenti e pozzi sono pratiche documentate in tutto l'arco albanese, da nord a sud, nei rituali pagani sopravvissuti sotto nomi cristiani o musulmani.
Ritorno alla memoria – Una donna anziana in abiti tradizionali osserva il mare al tramonto, immobile come una custode del tempo e delle origini, evocando il legame ancestrale con la terra e l’acqua
Le culture precristiane, come quelle illiriche e traco-pelasgiche, veneravano l’acqua come principio femminile. Le dee delle acque, le ninfe, gli spiriti dei laghi erano manifestazioni di una natura animata, di un mondo in cui ogni elemento visibile era abitato da presenze invisibili. Il lago non era solo una distesa d’acqua, ma una dimora. Il fiume non scorreva per caso, ma seguiva una volontà. Questo modo di sentire il mondo non è svanito con l’avvento delle religioni monoteiste: è rimasto incastonato nelle pieghe della vita quotidiana, nei gesti, nei proverbi, nei canti. La poesia popolare albanese non inventa questa visione: la eredita. La conserva e la trasmette, come una fiamma fragile ma costante, che attraversa i secoli. Non ha bisogno di miti complessi o di narrazioni articolate. Le bastano pochi versi per evocare un cosmo. Dire che “il mare contiene l’intero universo” è una dichiarazione totale, che sostituisce un intero sistema di pensiero. È filosofia condensata, è metafisica ridotta all’essenziale. E poi quei due versi finali – “da te siamo usciti, e a te ritorneremo” – dicono tutto ciò che serve per concepire una cosmologia: un’origine, una fine, e un legame che unisce entrambe. Non è solo poesia: è visione del mondo. Anche le religioni storiche presenti nei Balcani hanno finito per accogliere questa visione. Il cristianesimo, con il battesimo che immerge nell’acqua per rinascere. L’islam, con le abluzioni prima della preghiera, con l’acqua come purificazione e rinnovamento. Il bektashismo, con le sue pratiche simboliche legate ai luoghi d’acqua. La fede, anche quando cambia forma, continua a passare attraverso l’acqua. E così la strofa sul mare non è una semplice immagine. È il frammento di una religione perduta, o forse solo trasfigurata. Una religione della materia, del ciclo, della continuità tra visibile e invisibile. Una fede che non divide l’umano dal naturale, ma li intreccia. Ogni volta che un albanese canta il mare, c’è in quel canto qualcosa di più del paesaggio. C’è il ricordo di un’epoca in cui l’acqua parlava, e la gente ascoltava. Il mare non è solo un confine geografico: è un confine simbolico. È ciò che separa e unisce, che dà e prende, che nasconde e rivela. Il rispetto che si prova per esso non è reverenza romantica: è consapevolezza profonda. È sapere che l’acqua decide, che l’acqua comanda. È sapere che da lì veniamo, e che a lei, comunque, dobbiamo tornare. Anche chi vive lontano dal mare, nell’interno montuoso, lo porta dentro come idea, come eco. È negli occhi della nonna che scruta l’orizzonte anche se non l’ha mai visto. È nel silenzio dell’uomo che aspetta notizie dal figlio migrante. È nel gesto di portare l’acqua al campo con cura, come fosse un dono. Il mare non è solo un luogo: è una presenza costante. È una voce che chiama da lontano, e a cui si risponde senza parlare.
Con questi due versi si chiude il cerchio. Se il mare è all’origine della vita, esso è anche la sua fine. Ma non si tratta di una fine tragica o definitiva: è un ritorno. Nella visione contenuta in questa strofa, l’esistenza non è una linea, ma un ciclo. Si nasce dal mare e si torna al mare. Non si scappa, non si devia: si compie un percorso. Questa idea non è soltanto poetica. È profondamente spirituale. Il ritorno all’origine è una delle immagini più ricorrenti nelle religioni e nelle filosofie antiche. In Oriente si parla di samsara, il ciclo delle rinascite. Nelle culture mediterranee precristiane si credeva che l’anima ritornasse a fondersi con l’elemento primordiale. Nell’Ecclesiaste si dice che tutto torna alla polvere. Ma nella strofa albanese non è la polvere a richiamarci: è il mare. E questo fa una grande differenza. La polvere è arida, fredda, definitiva. Il mare è vivo, accogliente, infinito. Tornare al mare significa tornare in qualcosa che ci appartiene, che ci ha tenuto in grembo, che ci riconosce. È una dissoluzione che non fa paura, perché è un ricongiungimento. Anche in senso biologico questo ritorno ha un significato reale. Dopo la morte, il corpo umano si disgrega, e gli elementi che lo compongono – acqua, sali, minerali – ritornano al ciclo naturale. Molto spesso, finiscono nei fiumi, nei laghi, e infine nel mare. Non è metafora, è fisica. Nella cultura popolare albanese, questo ritorno non è descritto con terrore. È atteso, accettato, in certi casi persino desiderato. I canti funebri parlano di viaggio, di attraversamento, di approdo. La morte non è sparizione, ma passaggio. E dove si passa? Verso il det, verso l’acqua, verso quel grembo originario che ci aveva generati. Il mare, allora, diventa il nostro vero orizzonte. Non solo quello visivo, ma quello ontologico. È il confine ultimo, ma anche la promessa di continuità. Non c’è bisogno di paradisi ultraterreni, di ricompense divine. C’è il ritorno al tutto. Chi ha scritto questa strofa – o meglio, chi l’ha tramandata – forse non sapeva nulla di filosofia, religione comparata o biologia. Ma sapeva osservare. Sapeva ascoltare il ciclo delle stagioni, il corso dei fiumi, la forza del mare. E da quel sapere umile e profondo è nata una verità grande: che ciò che ha avuto inizio ha anche un luogo dove finire. E che quel luogo è lo stesso da cui tutto è partito. In un mondo che ha perso il senso del ritorno, che crede solo nell’accumulazione e nel progresso lineare, questa visione è rivoluzionaria. Ci ricorda che non siamo i padroni del tempo, ma suoi figli. Che non dobbiamo andare sempre avanti: a volte dobbiamo tornare. Tornare indietro, tornare all’origine, tornare al mare.
Quando oggi leggiamo quei versi – “nga ty kemi dalë / dhe prapë tek ti do të vijmë” – non stiamo solo riflettendo sul mare. Stiamo ascoltando una voce antica, che ci dice da dove veniamo, chi siamo e dove finiremo. Una voce che ci ricorda che l’uomo non è solo storia, ma anche mito. E se quella voce è ancora viva, è perché qualcuno l’ha ricordata, l’ha detta, l’ha cantata. E questo è il compito della memoria: custodire ciò che vale, anche quando il mondo cambia. Per questo la poesia popolare albanese è importante. Perché non è solo bellezza: è testimonianza. È il modo con cui un popolo senza grandi mezzi ha saputo dire grandi verità. E la verità che dice questa strofa è semplice e profonda: che il mare è tutto. Che da lì veniamo, e lì torneremo. E che in mezzo, nel breve spazio che chiamiamo vita, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti.
Ti è piaciuto questo contenuto?
Puoi approfondire e sostenere il blog acquistando uno di questi libri:
📘 Athleta Christi – 📕 I fatti più importanti – 📗 L’Enigma della lingua albanese
📚 Tre volumi, tre percorsi, un’unica identità da riscoprire
🔗 Tutti disponibili su Amazon – clicca sull'immagine per saperne di più











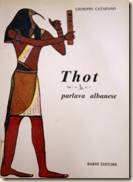

0 Commenti