Albania apre la porta (1992)
Albania apre la porta[1]
Di Dusko Doder
Fotografie di Nicole Bengiveno
Lexo artikullin në shqip Read article in EnglishDusko Doder, vincitore del premio Overseas Press Club per il suo reportage da Mosca, è un giornalista free lance con sede a Belgrado, in Jugoslavia. Il suo prossimo libro sull'Albania sarà pubblicato da Times Books. Nicole Bengiveno è fotografa del New York Daily News. Questo è il suo primo servizio per il GEOGRAPHIC.
Un autobus funzionante è un premio da accaparrarsi a Tirana, la capitale più povera d’Europa, dove i viaggi per trovare lavoro o beni spesso non portano da nessuna parte. Gli albanesi pagano ancora un prezzo pesante per i 40 anni in cui il dittatore stalinista Enver Hoxha ha tenuto la loro nazione isolata dal mondo.
Mentre il successore di Hoxha, Ramiz Alia (sopra), ha presieduto alla dissoluzione del comunismo in Albania, la generazione successiva - che ha brandito bandiere nazionali con la stella rimossa - ha chiesto una voce. “Prima avevamo un coniglio dentro di noi”, ha detto un artista malato di repressione, “ma ora un grosso cane abbaia in continuazione”.
Libertà è sinonimo di fuga per coloro che assediano l’ambasciata jugoslava per ottenere il visto o che si accalcano su una nave nella speranza di un passaggio per l’Italia - o per qualsiasi altro luogo.
Michel Setboun, Rapho/JB Pictures
Per gli imprenditori, libertà equivale a beni provenienti dalla Grecia, dove scambiano il bestiame con elettronica ed elettrodomestici.
“Fare la spesa per il cibo è come dare la caccia a una preda.”, racconta il fotografo Bengiveno. La carenza di cibo è cronica e le pagnotte di pane, prodotte da una fabbrica gestita dallo Stato, finiscono già nel pomeriggio. Così, quando il pane prodotto con la farina turca devoluta viene messo in vendita, la folla si accalca in un panificio obbligato a tenere le pagnotte chiuse dietro le porte sbarrate.
Uscendo dall’autostrada trafficata su una strada di campagna isolata, ho seguito i cartelli arrugginiti, lasciandomi alle spalle una nuvola di polvere e il mondo rumoroso della Jugoslavia, dirigendomi verso l’austera terra dell’Albania. A ogni chilometro la strada diventava sempre più stretta e accidentata, i secoli si allontanavano.
La chiamo strada per comodità. Mi sono chiesto se fosse stata tenuta deliberatamente in cattivo stato per scoraggiare l’invasione, un problema dell’Albania che permane dalla notte dei tempi. Sarebbero bastati pochi candelotti di dinamite per far cadere dei massi e sigillare il confine.
La strada montuosa da Saranda a Valona segue la frastagliata costa ionica. In basso, una spiaggia deserta si estende per chilometri. Off-limits sotto il regime di Hoxha, la costa non sviluppata potrebbe diventare una risorsa per il turismo.
Era il Capodanno del 1990. Mi avvicinai all’Albania per la prima volta, con un misto di incertezza e trepidazione. Come corrispondente estero, avevo vissuto in diversi Paesi comunisti, e questo aveva la reputazione di essere il più repressivo e paranoico di tutti.
Un Paese poco più grande del Maryland, con una popolazione di 3,4 milioni di abitanti, l’Albania stava appena aprendo le sue frontiere al mondo esterno. Sotto Enver Hoxha, che ha governato l’Albania come un latifondo feudale dal 1944 fino alla sua morte nel 1985, il Paese è diventato una capsula del tempo staliniana, una delle dittature più crudeli del mondo, dove alle mogli dei membri del partito caduti in disgrazia veniva ordinato di divorziare dai mariti, dove la barba era vietata, dove tutti i crediti e gli affari stranieri erano proibiti, dove la religione era bandita e dove criticare la scarsità di cibo poteva far finire in prigione voi e i vostri parenti. Persino i turisti erano sgraditi. Come disse Hoxha: “Perché dovremmo trasformare il nostro Paese in una locanda con le porte aperte a maiali e scrofe?”.
Ho guidato fino alla terra di nessuno, tra la Jugoslavia e la stazione di confine di Hani i Hotit, e ho fermato l’auto. Da qualche parte qui c’era l’epicentro del mio mondo. Dietro di me, sulle montagne montenegrine, c’era la casa d’infanzia di mio padre; davanti a me, a 20 miglia a sud, sorgeva la città di Scutari, dove vivevano i miei nonni materni.
L’aria era umida, profumata di fiori dell’Adriatico. La mia serenità è stata interrotta da un gruppo di viaggiatori jugoslavi, ormai stremati. Trascinavano borse e valigie lungo una strada senza vita, a un solo binario, verso rotoli di filo spinato e guardie dal volto truce che sorvegliavano il confine con l’Albania. Ho fissato a lungo i viaggiatori.
Se la mia nonna paterna, rimasta vedova, non si fosse trasferita a St. Louis con i suoi figli e le sue figlie, avrei potuto essere tra quelle persone che trascinavano le loro valigie verso il confine. Ma sarei ancora io? Ero uno di loro? Questo sarebbe diventato il mio pensiero ricorrente nel mio viaggio in Albania, che avrei visitato sei volte nel 1991, proprio mentre il Paese stava compiendo la sua dolorosa transizione dal comunismo e dalla demenziale eredità di Hoxha.
La guardia di frontiera ha chiuso un cancello di ferro e mi ha sorriso. Mi indicò dove parcheggiare, poi salì i gradini della squallida stazione doganale. Lo seguii.
Un altro gruppo di uomini e donne stava lasciando la prima di una serie di visite consentite in Jugoslavia, dove hanno rivisto i parenti da cui erano stati tenuti lontano per più di quattro decenni.
Senza parole, una guardia di frontiera trentenne ha sfogliato il mio passaporto, soffermandosi su ogni timbro come se contenesse un codice segreto. Quando ha finito, ha passato i miei documenti a un altro uomo e poi mi ha sbalordito rivolgendosi a me in un inglese impeccabile.
“Vieni, lascia che ti offra da bere mentre aspetti il passaporto”. Aveva imparato l’inglese ascoltando trasmissioni in lingua straniera alla radio, un reato punibile con il carcere sotto Hoxha.
La guardia mi condusse via, sorseggiammo un caffè zuccherato e un Riesling albanese dolce in un’altra stanza. Ha insistito per pagare, una caratteristica tipicamente locale per l’ospitalità che avrei incontrato più volte. E non ha protestato quando ho adagiato una stecca di sigarette sulla sua scrivania. Dopo pochi minuti dall’ingresso in Albania, scoprii che nemmeno il più orwelliano dei dittatori era riuscito a sopprimere completamente la natura umana. Qui c’era speranza.
Desiderosa di essere al centro delle cose, sfrecciai lungo la strada verso la capitale, Tirana, rammaricandomi di sapere così poco dei miei antenati. Non mi ero mai chiesto perché i genitori di mia madre si fossero trasferiti in Austria-Ungheria, ma senza dubbio erano partiti per lo stesso motivo per cui migliaia di albanesi emigrano oggi, per cercare una vita migliore.
I genitori e i quattro fratelli della madre erano morti quando lei era ancora adolescente e non ha mai messo piede in Albania. Dopo essersi sposata creando una famiglia serba, ha dovuto nascondere la sua identità e, dopo la presa del potere da parte dei comunisti, non ha più avuto contatti con l’Albania.
Anche dopo la morte di Hoxha e la rivoluzione che nel 1989 spazzò via il comunismo dal resto dell’Europa orientale, l’Albania rimase un Paese a parte, ancora ostinatamente comunista, una terra che si era allontanata dal mondo conosciuto e che intendeva rimanere tale. L’erede di Hoxha, Ramiz Alia, ha mantenuto la tradizione draconiana.
Solo nel 1990 le ondate rivoluzionarie hanno iniziato a riversarsi nel Paese dell’Aquila, come gli albanesi chiamano il loro Paese. A luglio una folla di 5.700 persone prese d’assalto le missioni straniere a Tirana, chiedendo al governo di poter emigrare. A dicembre gli studenti sono scesi in piazza chiedendo riforme, sono scoppiate rivolte e l’economia subì un blocco. Si è formato il primo partito alternativo e sono stati rilasciati alcuni prigionieri politici. Il governo di Alia fu costretto a indire elezioni multipartitiche; nel marzo 1991 fu eletto un parlamento pluralista.
L’incubo di Hoxha stava finalmente finendo. Ma presto scoprii che ci sarebbero voluti anni, forse generazioni, perché l’Albania si mettesse al passo con il mondo moderno. Guidando per quasi un’ora attraverso la campagna, non ho visto altre auto. Di tanto in tanto, in un vortice di polvere, appariva un camion di fabbricazione cinese, dal muso di pecora e indistruttibile. Mucche, maiali, anatre e galline, che si muovevano lungo la strada in totale squilibrio, mi rallentavano. Così come carriole e carri a buoi, che condividevano la strada con contadini a piedi e su asini.
Ho visto tre scolari, di non più di dieci anni, in piedi lungo la strada e mi sono fermato a prenderli. Indossavano una sorta di uniforme scolastica, abiti neri con fazzoletti rossi al collo. Non potendo parlare la loro lingua, ho offerto a ciascuno di loro una banana. Ridacchiarono nervosamente e rifiutarono di mangiare. Dubito che avessero mai visto il frutto prima. Ho avuto anche l’impressione che non fossero mai stati in un’autovettura. Non sapevano come sedersi, come aprire la portiera. Una delle ragazze mi fissava a bocca aperta.
Non più isolati, gli ex prigionieri politici cercano un risarcimento per le loro famiglie emarginate. Gjon Mark Ndou (sopra, in giacca scura) è stato imprigionato in una cella angusta per 25 anni. Per loro stessi e per la nazione, dice un intellettuale albanese, “hanno bisogno di raccontare le loro storie”. A maggio gli operai del governo hanno rimosso le spoglie di Enver Hoxha dalla sua tomba regale (sotto) per essere riseppellite in un cimitero pubblico.
Non appena ho fermato l’auto e aperto la portiera per farli uscire, si sono precipitati lungo il pendio della montagna come se fossero appena fuggiti da un’astronave.
Le città che ho attraversato avevano un aspetto spoglio e disordinato; i negozi erano malandati e praticamente vuoti. In un negozio ho trovato solo due sacchi di patate, quattro cavoli ammuffiti e qualche scatola di pesce.
L’esperienza ha sottolineato quanto la propaganda socialista del progresso di Hoxha fosse un pezzo di teatro balcanico. Sebbene il dittatore fosse morto da più di cinque anni, il suo spirito continuava a vivere. All’inizio del 1991 la statua di Hoxha dominava ancora ogni città e paese, con il suo volto ritoccato per apparire bello, saggio, premuroso e paterno.
Sono entrato a Tirana proprio quando la capitale si stava svegliando dal suo lungo sonno. Tra la sbiadita grandezza delle piazze e delle strade principali, la gente speranzosa parlava di poco altro che di politica.
Lavorando a macchinari di fabbricazione sovietica e cinese vecchi di una generazione, un operaio compie lenti progressi in una fabbrica che trasforma rottami metallici in parti di trattori. All’inizio del 1992 il salario medio settimanale era di soli 250 lek, circa cinque dollari, e la disoccupazione si avvicinava all’80%. Gli economisti occidentali sostengono che per disfare decenni di pianificazione centrale staliniana ci vorranno altri dieci anni. Anche l’iniziativa deve essere appresa. I funzionari dell’Università di Tirana vogliono invitare gli economisti statunitensi per aiutarli a formare i membri della facoltà. Ma, dice un vicerettore, “non abbiamo davvero idea di come iniziare a prendere contatti”.
A Tirana (sopra) un fiume di passeggiatori sale ogni sera. Con pochi telefoni a disposizione, è il modo tradizionale per raggiungere gli amici. Nuovi al traffico, i contadini di Scutari (sotto) carichi di foraggio in steli di mais possono ora commercializzare liberamente
Taglialegna, operai, studenti e impiegati stavano in mezzo alla strada, chiacchierando come se volessero recuperare il tempo perduto.
Centinaia di loro affollavano ogni giorno gli uffici del nuovo Partito Democratico. In questo gelido pertugio - la villa che il governo comunista aveva concesso al nuovo partito non aveva riscaldamento - si discuteva animatamente di libertà di parola, un concetto estraneo a persone che per decenni non avevano potuto confidare a vicini o amici i loro pensieri più intimi. I lavoratori venivano a chiedere aiuto per organizzare scioperi, un concetto estraneo all’Albania di Hoxha.
Un giorno stavo tremando in ufficio quando un giovane attivista di nome Arsem Kaustic entrò, mi strinse il braccio e non lo lasciò più mentre parlava, con grande indignazione, dei delinquenti comunisti che erano ancora all’opera nelle campagne. Avevano cercato di ostacolare i suoi sforzi per organizzare il Partito Democratico nella piccola città di Laç. Avevano minacciato di uccidere qualsiasi riformatore che si fosse candidato. Non conoscevano la decenza.
Una donna anziana con gli occhi azzurri sbiaditi è venuta a raccontarmi come Hoxha abbia imposto l’ateismo. “Ha portato via mio marito più di 30 anni fa perché leggeva la Bibbia. Mio marito è morto in prigione”, disse singhiozzando. “La maggior parte dei sacerdoti sono stati uccisi o sono morti in prigione. Tenevamo la nostra fede chiusa nel cuore, non osavamo parlarne con nessuno”.
Se ne andò. Un gruppo di uomini irrompe e una figura scarna con un berretto di stoffa marrone inizia a gridare. Annunciò il suo nome, Gjelosh Gega, e la sua condizione: “Sono un prigioniero politico! Sono stato rilasciato! Volevo venire a ringraziare il Partito Democratico!”.
Fece un sorriso di pura gioia, scoprendo un unico dente. Gega mi raccontò che gli altri erano stati colpiti a sprangate da una guardia di frontiera quando, sei anni prima, lui e un suo compagno avevano tentato di fuggire dall’Albania. Gega, allora ventenne, era stato condannato a 18 anni. Era stato fortunato. Le guardie avevano ucciso il suo compagno con un colpo di pistola.
Questa nuova generazione, ho appreso, voleva cancellare tutto ciò che era legato a Hoxha. “Basta guardare i nostri vicini. Hanno fatto tutti meglio”, ha detto Azem Hajdari, un tarchiato studente di filosofia di Tropoje che in seguito sarebbe diventato membro del Parlamento. A poche settimane dal nostro incontro, Hajdari ha guidato gli studenti per rovesciare la statua di Hoxha posizionata nella piazza centrale di Tirana, non lontano da un grottesco museo moderno pieno di curiosità sulla vita del dittatore.
“Voglio trasformare il museo Hoxha in una discoteca gigante”, ha confidato Gramoz Pashko, professore di economia e cofondatore del Partito Democratico.
Una volta che gli albanesi si sentirono liberi di parlare, la trasformazione dal comunismo fu rapida. Nel febbraio 1991 scoppiarono gli scioperi e i manifestanti all’Università di Tirana vennero cosparsi di coriandoli fatti con gli scritti di Enver Hoxha, le cui parole un tempo erano state trattate con venerazione biblica.
“Enver”, gridò la folla, “sei un ladro! Dove sono i nostri soldi?”.
La vita albanese è di tipo piccolo-borghese, quindi si è subito sparsa la voce che la famiglia di mia madre era originaria di qui. La gente si avvicinava a me, chiedendomi di recitare frasi e filastrocche della mia infanzia. Ogni volta che lo facevo, la risposta era la stessa: scrosci di risate seguiti da una valanga di parole che non riuscivo a capire. Era sufficiente a garantirmi l’accettazione, l’ingresso immediato in una società che aveva trascorso decenni a perfezionare la propria diffidenza. Mi sorridevano come per dire: sì, è straniero, ma è uno di noi. Uno di noi. Ha vissuto fuori dalla prigione e forse ora lo faremo anche noi.
“Dimmi onestamente”, ha detto un uomo sui 30 anni. “Cosa pensa di noi il mondo esterno? Siamo davvero così arretrati? Le cose qui sono davvero così terribili? Rispetto all’esterno? Per favore, ditemi onestamente”. Si rannicchiò contro il freddo nel suo cappotto nero e logoro, aspettando la risposta.
È stato difficile dirgli che, sì, il suo Paese era molto arretrato e molto povero.
“E possiamo diventare parte dell’Europa; la differenza è così grande?”. La domanda era di una donna. Certo, le dissi, con il tempo. Ho giudicato che avesse circa 40 anni, ma non potevo esserne certo; il suo bel viso era segnato da profonde rughe di preoccupazione. Sembravano permanenti.
Tra i miei nuovi amici c’era il cameriere Bushy, sempre con il papillon e sempre pronto alla battuta. (C’era la telefonista Raymonda, elegantemente vestita perché suo marito, Sofocle, a volte guidava il suo camion fino in Jugoslavia e tornava con molti beni di valore. E la vivace Flutra, che stava organizzando un matrimonio autunnale. (“Lei e sua moglie siete invitati”, mi ha detto).
Questi nuovi amici mi hanno aiutato a capire l’Albania. Bashkim, un attivista del Partito Democratico, mi invitò al primo sciopero dei minatori, nella miniera di Valias, fuori Tirana. Quando arrivai con la mia Mercedes-Benz, i minatori si voltarono, applaudendo e fischiando. Indicarono l’auto e mostrarono il segno della V di vittoria.
“Che cosa mai hai detto loro?”. Ho chiesto a Bashkim più tardi.
“Ho detto loro che sogno un giorno in cui questo cortile sia pieno di auto come la vostra, tutte guidate da minatori!”.
Ma altri attivisti avevano una visione più realistica dell’economia altalenante dell’Albania. “Dio ci salvi dall’avere il potere”, ha detto il mio amico Gramoz Pashko, che vedeva che l’Albania aveva smesso di funzionare per il momento, in bilico tra socialismo ed economia di mercato. “Non sarà facile cambiare un sistema completamente collettivizzante”, mi disse.
Non un solo caffè o negozio privato illuminava le tetre strade di Tirana mentre l’inverno del 1991 scivolava verso la primavera. In effetti, sbirciando nelle porte e nelle finestre dei negozi della capitale, ho visto spesso donne curve sul lavoro come figure uscite da Dickens, che lavoravano alle macchine da cucire nel buio, pedalando furiosamente per far funzionare gli aghi.
Dopo le prime elezioni multipartitiche in Albania, il Paese è entrato in una nuova fase senza segnare adeguatamente la fine di quella precedente. Figure chiave dell’opposizione, come Sali Berisha e Gramoz Pashko, erano stati essi stessi membri del Partito Comunista solo pochi mesi prima.
Anche se i comunisti hanno ottenuto il 65% dei voti espressi nella primavera del 1991, le elezioni hanno prefigurato la fine del comunismo in Albania. L’opposizione ha conquistato praticamente tutte le città. Solo nelle campagne i comunisti hanno vinto. Ramiz Alia era ancora presidente, ma sembrava consapevole di essere una figura transitoria che poteva fare poco più di un senso di stabilità, a cavallo tra i regimi del passato e del futuro.
Per la maggior parte della sua vita, mia madre si sentiva a disagio per la reputazione dell’Albania come strano e orribile stato di polizia, e raramente ne parlava. Ma quando raggiunse i 70 anni, avvenne un cambiamento. Cominciò a parlare del suo desiderio di visitare Scutari, la città dei suoi genitori. Nella sua immaginazione Scutari divenne più attraente ed esotica di qualsiasi altro luogo che avesse visitato: la Grande Muraglia cinese, il Vaticano, il Grand Canyon. Scutari faceva parte di una categoria a sé stante, di cui parlare con molto orgoglio, con un’eleganza particolare. Non fece mai il viaggio.
Quando sono arrivato lì, all’inizio di aprile, la città era in disordine. I manifestanti affollavano le strade, sostenendo che i comunisti avevano vinto le elezioni nelle campagne, dove vivono i due terzi della popolazione, con l’intimidazione.
“Siamo a corto di tutto, dalle bende alle valvole cardiache”, dice un medico del pronto soccorso di Tirana, che cura una ferita alla testa come meglio può. Le scarse medicine provengono in gran parte da donazioni europee e statunitensi. Il momento dell’allattamento sembra dolce nel reparto maternità, ma i tassi di mortalità rimangono alti a causa della scarsità di attrezzature e dell’alimentazione inadeguata per le donne in gravidanza. Ogni anno i genitori disperati sono costretti a cercare cure per 70.000 bambini malnutriti.
Una bonanza per giovani mani desiderose, un’auto abbandonata viene ripulita. Questi ragazzi sono i primi di due generazioni a crescere con gli orpelli della cultura pop occidentale. Per loro, le magliette inviate dai parenti emigrati sono di gran moda. Nel frattempo, i loro giocattoli sono dove li trovano, persino in una scatola vuota (sotto).
La polizia ha aperto il fuoco, uccidendo quattro giovani attivisti del Partito Democratico e ferendone decine di altri. La folla si è scatenata e ha bruciato la sede del Partito Comunista. Il fumo nero si è sprigionato dall’edificio mentre guidavo in città, passando accanto a un veicolo blindato, rovesciato e sventrato.
Mi è piaciuto lo spirito di sfida di Scutari, forse un residuo dell’orgoglio che ha reso questa città la capitale dell’antica Illiria, il cui ultimo re, Gentius, fu sconfitto e fatto prigioniero dai Romani nel 168 a.C.
La storia della città è l’avvenimento tortuoso dell’Albania. Dopo Roma, qui ha regnato Bisanzio, seguita da ondate di conquista da parte di Goti, Serbi, Bulgari, Normanni, Veneziani, Turchi Ottomani, Italiani e Tedeschi.
Un’eredità della dominazione ottomana è che l’Albania è l’unico Paese europeo a maggioranza musulmana. Nel 1967, quando Hoxha dichiarò l’Albania uno Stato ateo, circa il 70% della popolazione era musulmana, il 20% ortodossa albanese e il 10% cattolica romana. I feroci tentativi di Hoxha di sradicare tutte le religioni sono serviti a rafforzare la tolleranza religiosa che esiste da secoli.
Ho trovato la gente di Scutari ospitale e amichevole. Ho iniziato una conversazione con Marash e Domenika Selmani e ho chiesto di mio nonno Gjurchu.
“Mai sentito questo nome”, disse Marash, dando la stessa sconfortante risposta che avevo trovato in giro per la città.
“Beh, che ne dici di Kosmaçi?”. Chiesi, provando il nome della zia della mamma.
“Certo!” Marash rispose con un sorriso. "L'insegnante Pjerin Kosmaçi nella nostra scuola. Vi porteremo da lui”. Seguendo un vicolo, arrivammo a una minuscola casa a schiera in via Skanderbeg. Non vidi nulla di familiare nel volto di Pjerin Kosmaçi, l’insegnante che viveva lì con la moglie, il figlio neonato e la madre di Pjerin.
Il nostro ospite era diffidente. Il caffè è stato servito, si sono scambiate frasi di circostanza e, gradualmente, l'atmosfera si è scaldata. Tuttavia, c'è stata anche una dose di delusione. “Non sono proprio tuo cugino”, disse infine Pjerin. “Credo che tuo cugino possa essere Jack Kosmaçi, che vive in un’altra città.
vicino a Durazzo”. Potrei avere il numero di telefono di Jack?
La parola “telefono” ha provocato uno scoppio di risate convulse. Il mio ospite, sua madre di 71 anni e le mie amiche Marash e Domenika hanno reagito come attori di una sitcom televisiva, ripetendo la parola e ridendo e roteando gli occhi. Il telefono - ce n’erano solo 6.000 in tutto il Paese - era il simbolo del massimo privilegio. Qui non c’è nulla di tutto ciò. Ma Pjerin compensò la mia delusione scarabocchiando l’indirizzo di Jack Kosmaçi su un pezzo di carta e porgendomelo.
Ci sarei arrivato il prima possibile, ma prima ero ansioso di incontrare il vicino e cugino di Pjerin, un sacerdote cattolico romano di nome Simon Jubani.
Aveva 65 anni ed era molto fragile per i 26 anni trascorsi in una delle carceri più dure dell’Albania. Ma padre Jubani era ancora capace della ferocia che lo ha reso un eroe nazionale. Non molto tempo dopo il suo rilascio, nel 1990, affrontò il divieto di culto imposto dal governo guidando decine di cittadini alla chiesa locale. Sorvegliato da giovani scutarini armati di coltello, padre Jubani si mise in piedi tra le erbacce, tra lapidi a lungo trascurate, e iniziò a intonare la prima Messa pubblica di Scutari in più di due decenni. Quando ha finito, migliaia di persone, musulmani e cattolici, hanno affollato il cimitero e si sono riversate nelle strade. Le autorità hanno fatto marcia indietro e la chiesa di padre Jubani è stata riaperta.
Mi invitò nel suo ufficio, dove una fotografia incorniciata del suo incontro con Papa Giovanni Paolo II attestava il suo nuovo status dopo gli anni di abbandono. Padre Jubani sapeva che il futuro sarebbe stato molto difficile.
“È difficile passare da uno Stato tribale a una democrazia”, mi ha detto. La transizione avrebbe richiesto tempo, ma gli albanesi avevano già dimostrato la loro capacità di recupero. Mi ha ricordato che nemmeno Hoxha era riuscito a distruggere la religione, così come non aveva distrutto uno degli attributi più forti dell’Albania, besa, ovvero la parola promessa.
“Quando Enver Hoxha è salito al potere, la besa era besa”, ha ricordato padre Jubani. “Ma Hoxha ha cercato di sostituirla con corruzione, bugie e ignoranza”.
Ah, besa. Mi sono ricordato di un vecchio detto: “L’albanese ucciderà prima suo figlio che rompere il suo voto”. Da bambino avevo sentito questa frase pronunciata con una solennità che non ha eguali, e mi era stato insegnato a onorare la mia parola, a prescindere da tutto. È ancora impressa nel mio cervello e vive nella mia anima. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, l’Albania era stata una società essenzialmente tribale e feudale, legata alle tradizioni della famiglia e della fedeltà - e sempre della besa.
Nell’antica Albania la besa non era solo un codice morale, che in altre società costituisce il fondamento della virtù e dell’etica. La besa era una legge che per secoli è servita come regolatore della vita quotidiana. Regolava gli affari conclusi dai singoli individui, dai villaggi e dai clan, o addirittura dai distretti. Violare la besa non rappresentava soltanto la più grande infamia, ma chi commetteva tale atto si esponeva anche alla più severa delle punizioni: l'esecuzione sommaria ad opera dei suoi stessi pari. Un mio amico albanese di nome Chim Beqari, che mi ha aiutato a guidare tra le montagne e mi ha fatto da interprete, mi indicava spesso le rovine delle case di coloro che avevano rotto la besa, dove le pietre delle fondamenta erano sparse come previsto dalla legge non scritta. Gli albanesi non si puniscono più in questo modo, ma a poco a poco mi resi conto che molte persone erano ancora riluttanti a promettermi qualsiasi cosa, per quanto piccola, come riparare una luce nella mia camera d’albergo, forse per paura di fare un voto che non avrebbe potuto essere onorato.
Guidando dalle aspre montagne verso la costa adriatica, Chim e io arrivammo finalmente a Shijak, il villaggio dove speravo di trovare Jack Kosmaçi. Potrebbe essere il mio unico legame vivente con l’Albania.
Portando con me una bottiglia di brandy francese e una scatola di buon tè che avevo comprato come regalo in un negozio di valuta forte a Tirana, attraversai la piazza del villaggio per iniziare le indagini. Uno degli uomini presenti conosceva la famiglia. “Ah, Kosmaçi, il muratore”, mi disse l’uomo, indicandomi con fare gentile la piazza del suo edificio.
Salendo a fatica le scale di cemento, ogni gradino di un’altezza diversa, trovai la casa di Jack Kosmaçi. Lo studiai attentamente alla ricerca di segnali di familiarità. Avevo già visto quelle sopracciglia, quel naso a fessura, nella mia famiglia? Aveva una certa dignità, come le figure delle vecchie fotografie appese alle pareti del suo appartamento.
Ho esaminato un ritratto di famiglia con 15 persone.. Al centro si ergeva un ufficiale militare adornato di medaglie e distintivi, affiancato da un uomo anziano in vistosi pantaloni alla turca e un gilet arricchito da una massiccia catena d'oro. Accanto a lui, due giovani uomini, impeccabilmente vestiti, indossavano eleganti giacche da sera. Le donne, nel frattempo, sfoggiavano abiti che sembravano usciti direttamente dalle ultime passerelle della moda parigina. Mentre Chim spiegava la mia presenza, gli occhi di Jack passarono dall’interprete a me, poi di nuovo a me, quindi si fissarono su di me. Lo sapevamo. Annuì, sorrise e strinse di nuovo la mano, questa volta più forte. Stabilimmo rapidamente dei rapporti. La nonna paterna di Jack era una Gjurchu, sorella del mio nonno materno. Jack era mio cugino.
Abbiamo parlato tutta la mattina. Il racconto di Jack ha dato una dimensione del tutto nuova agli orrori dell’epoca di Hoxha. Ero passato davanti a una delle famigerate prigioni albanesi, un luogo chiamato Burrel, ma ora era diventato un luogo reale, così come un altro chiamato Spaç. I membri della nostra famiglia erano stati in entrambe.
Jack ha ricordato il giorno in cui presero suo padre, Anton Kosmaçi. Era il 1944, il mondo era ancora in guerra, ma i tedeschi avevano abbandonato l’Albania. Tirana, dove vivevano i Kosmaçi, era già nelle mani di Enver Hoxha e dei comunisti. Jack aveva 15 anni.
I soldati bussarono alla porta e chiesero di Anton. Egli abbracciò la madre di Jack. Abbracciò Jack. Non c’era tempo per le lacrime.
“Povera mamma”, ha ricordato Jack. “Lei lo sapeva. Mi chiese di seguire papà, ma di tenermi a distanza”. La camminata verso la sede della polizia durò 15 minuti, non di più, e ogni dettaglio rimase nitido nella memoria di Jack: Il rumore dei passi degli uomini che scricchiolavano sulla ghiaia, suo padre che camminava a testa alta in un cappotto nero con un sottile collo di pelliccia, il viale fiancheggiato da vecchie querce e salici senza foglie, il fiume Lana che scorreva freddo attraverso la città,
suo padre che si voltava per salutare prima di scomparire nel recinto delle
mura.
Lavoro o sciopero? I bollettini esposti alla finestra di un ufficio di Tirana segnano la nascita della democrazia, mentre gli scioperi generali della primavera del 1991 chiudono fabbriche e miniere. Con tutti i guasti alle attrezzature e gli scioperi, lamentava l'allora presidente Alia, "nessuno lavora più".
Anton fu condannato a 30 anni di carcere come “nemico del popolo”, dieci anni per ogni mese in cui era stato ministro della Giustizia in uno dei governi che si erano succeduti durante l’occupazione italiana. Molto provato dagli anni di prigione, fu rilasciato nel marzo 1964 in virtù di un’amnistia generale. Tutti i vicini lo conoscevano come nemico del popolo e lo trattavano come un lebbroso. Morì pochi mesi dopo.
“Com’è possibile che tua madre non ne sappia nulla? Nessuno gliel’ha mai detto?”. Mi chiese Jack. Versò un altro bicchiere di raki per ciascuno di noi e mi scrutò, come se la mia conoscenza della sofferenza di suo padre potesse alleviare il dolore di tutti gli anni perduti. Cosa potevo dire a questo dolce uomo dai capelli bianchi? Non avevo mai saputo della sua esistenza fino a quella casuale indagine a Scutari.
Lui ha capito. Mi fece un sorriso e continuò. “Non bastava che Hoxha mettesse mio padre in prigione. La famiglia doveva essere perseguitata per la vergogna”. La madre di Jack fu mandata in un campo di lavoro a Tepelenë, la nonna in un ospedale carcerario fuori Tirana. L’istruzione di Jack si interruppe. Il regime lo fece diventare un muratore. L’esilio finale della famiglia fu nel villaggio di Shijak, dove li trovai.
Anche i due figli di Jack, Alexander e Blendi, hanno sofferto in quanto nipoti di un nemico del popolo. Non poterono frequentare la scuola oltre la terza media. Entrambi sono diventati meccanici.
“Ero addolorato, ma era così che doveva andare”, ha detto Jack. “Vivevamo tutti in una grande prigione”. Fece una pausa di circa un minuto.
Via Kavaja, ore 5. Dafina Prifti è la prima a fare la fila al negozio di distribuzione del latte nel suo quartiere di Tirana. Le forniture variano. A volte il latte è razionato, altre volte non c’è. A volte c’è solo latte in polvere (se non è stato rubato dalle spedizioni degli aiuti esteri). La fila può formarsi già a mezzanotte per l’apertura all’alba. L’estate scorsa, quando agli agricoltori della cooperativa è stata concessa una piccola quota di terra, molti hanno iniziato a lavorare solo per sé stessi. I raccolti della cooperativa si sono esauriti, così come il cibo sugli scaffali delle città, generando razionamenti e sporadiche rivolte alimentari.
Vidi una crepa nel suo controllo mentre lottava per continuare. “Jackie, Jackie”, disse sua moglie Anna, che era rimasta seduta in silenzio. Quando riprese, la sua voce cambiò timbro, la rabbia aumentò.
Il 1° giugno 1990, giornata dell’infanzia in Albania, le due bambine di Alexander, di otto e nove anni, dovevano partecipare a una recita per i genitori. Jack ricorda che: “Hanno provato diligentemente.
Il giorno prima dello spettacolo, un membro del comitato del partito Shijak è venuto a scuola e ha detto al regista che le ragazze di Alexander dovevano essere rimosse dalla rappresentazione”.
Nemici del popolo. Jack fece una lunga pausa. “Per punire cinque generazioni! Cinque generazioni! Qual era il crimine che meritava una tale punizione? Non c’è stata un’accusa specifica rivolta a mio padre, nemmeno una!
“Devo raccontarti la vera tragedia”, disse, ora quasi in un sussurro, come se mi stesse svelando il segreto della vita. “Il giorno in cui i miei nipoti furono puniti, i miei due ragazzi giurarono che sarebbero fuggiti da questa terra. Fuggire ad ogni costo. Per quanto tempo dovremo soffrire? Neanche i miei nipoti saranno assolti?”.
Sia Alexander, 35 anni, che Blendi, 21 anni, hanno mantenuto la loro parola. Sono fuggiti dall’Albania nel marzo 1991. “Non sono preoccupato per Blendi”, mi ha detto Jack. “È giovane. È in Italia. L’Albania ha buone relazioni con l’Italia. Possiamo parlare al telefono nel mio ufficio postale.
“Ma Alexander...” Sospirò profondamente. “Mi preoccupo per lui ogni giorno. Ha una moglie e due figli ancora qui. È in un carcere jugoslavo dove tengono i rifugiati. Vuole andare in America, in Canada o in Australia. Ma nessuno accetta gli albanesi di questi tempi”.
Ho presentato i miei doni di brandy e tè a Jack e Anna e ho promesso che avrei cercato di aiutare Alexander. La mia besa. I loro occhi lacrimarono e capii che avevo appena dato loro l’unica cosa che avevano segretamente sperato. Gettai un braccio intorno a Jack mentre uscivamo a passo di marcia
nella luce del giorno, come due cugini, seguiti da Anna, dalla moglie di Alexander, Rita, e dalle sue figlie. “Promettimi che tornerai”, disse Jack. Lo promisi.
In tutta l’Albania rurale ho trovato persone rassegnate alla loro sorte, ma che di tanto in tanto si concedevano piccoli piaceri sconosciuti sotto Hoxha. “Stiamo cercando di divertirci e di non pensare al domani”, mi ha detto Namzo Guzin, un giovane contadino che ho incontrato nel villaggio di Borçë, vicino al mare Adriatico. Alcuni amici di Namzo si stavano sposando e l’intera comunità si era riunita per una serata di divertimento.
“Stasera, speriamo”, ha detto Namzo, 35 anni. “È il primo matrimonio a cui partecipo. Ed è il primo bicchiere che alzo per brindare a qualcuno che non sia Enver e la festa”. Namzo e sua sorella si sono uniti agli altri che eseguivano furiosamente il Napoleoni, una danza nuziale che prende il nome dalle monete d’oro che gli invitati erano soliti lanciare alle giovani coppie nell’era precomunista. Qui di oro non se ne vedeva.
Il toastmaster ha proposto un’altra bevanda, che ha provocato un vero e proprio tumulto. “Era un brindisi per la nostra gente all’estero”, mi spiegò Namzo. “Quasi tutti i presenti hanno qualcuno in Italia. Il fratello dello sposo è fuggito a marzo, il marito di mia sorella ad aprile”.
Vivere in Albania sarà sempre più difficile. Negli ultimi mesi del 1991 la gente era disperata. L’eredità di Hoxha era stata spezzata, ma anche la disciplina. Nessuno lavorava. Ho incontrato diversi meccanici dell’ex stabilimento tessile Enver Hoxha di Tirana che non andavano al lavoro da marzo. Eppure ricevevano ancora l’80% della loro paga. Lo stesso accordo valeva per i dipendenti dell’unica fabbrica di vetro del Paese, che aveva interrotto la produzione nel 1990 perché non riusciva più a procurarsi le materie prime. Una cosa tira l’altra. A causa della carenza di vetri per proteggere dal freddo, scuole, fabbriche e uffici sono stati costretti a chiudere. E per gli uffici e le scuole ancora aperti, spesso non c’era riscaldamento, perché la produzione di carbone era insufficiente.
In diverse comunità sono scoppiate rivolte per il cibo. A Fushë-Arrëz, una città di legname nelle montagne, i manifestanti affamati hanno marciato sul deposito alimentare locale dopo le voci di un’imminente carenza di pane. Venti poliziotti non sono stati all’altezza di fronteggiare a una folla di 2.000 persone, che hanno dato fuoco all’edificio. Più di 30 persone sono morte nello scontro.
Gli amici albanesi concordano sul fatto che la crisi alimentare è peggiorata da quando i comunisti hanno perso il potere. “Prima, la distribuzione di cibo veniva mantenuta grazie alla paura”, ha spiegato un uomo che era stato un alto funzionario del governo. Ora le persone in campagna facevano incetta di cibo, il che significava che gli abitanti delle città di Tirana dovevano mettersi in fila nel cuore della notte per ottenere le scarse scorte di latte del mattino successivo.
“Anche se ti metti in fila così presto, non hai la garanzia di ricevere il latte”, mi ha detto un’anziana signora. Ne aveva bisogno per i suoi nipoti.
Il raccolto di mais aiuterà una famiglia di contadini nelle Alpi dell’Albania settentrionale a superare l’inverno; la loro vita è un regime massacrante condiviso da due terzi della popolazione. La tradizione vuole che la sposa Flutura Kadria, in un villaggio di montagna vicino a Kukës, abbia un aspetto sconvolto nel lasciare la sua famiglia. Qualsiasi cosa di meno sarebbe un insulto mentre si preparano a darla in sposa.
Gran parte della campagna è stata spogliata per ricavarne combustibile, ma a Fier alcuni alberi sono sfuggiti all’ascia dei taglialegna e di tanto in tanto un uomo può ancora portare a casa una grassa oca dal mercato. Questi semplici piaceri sono tutto ciò che la maggior parte degli albanesi può ancora sperare.
Ai viaggiatori è stato consigliato di portare con sé del cibo durante i viaggi nel Paese. Un diplomatico greco che guidava da Atene a Tirana è stato fermato, derubato di tutto e autorizzato a proseguire solo con la camicia e i pantaloncini.
Questi traumi non fecero altro che intensificare la lotta politica a Tirana. L’Albania entrò nel 1992 in una spirale fuori controllo. Le forze democratiche di opposizione chiesero nuove elezioni in primavera e ottennero il 62% dei voti, ottenendo il controllo del nuovo parlamento di 140 seggi.
Ramiz Alia, l’ultimo retaggio del regime comunista, si è dimesso in aprile. È stato sostituito da Sali Berisha, fondatore del Partito Democratico e leader carismatico.
La maggior parte degli albanesi sa cosa vuole: una società civile, un’economia di mercato, un governo parlamentare e il rispetto dei diritti umani.
Il Paese sta entrando in una transizione dolorosa che potrebbe durare diversi anni. Le sfide sono chiare: l’Albania deve superare una psicologia disfattista radicata da anni di repressione, allentare la presa della burocrazia consolidata nelle campagne, convincere i giovani (il 60% della popolazione ha meno di 25 anni) a restare, mantenere la tolleranza religiosa e soprattutto rianimare un’economia moribonda.
Ci sono alcuni segnali di speranza. Gli investitori stranieri stanno iniziando a visitare l’Albania, intravedendo possibilità nelle sue spiagge panoramiche, nelle montagne innevate e nei depositi di petrolio, cromo e rame.
Ci sono piani per sviluppare le bellissime spiagge lungo il Mar Ionio. Ma le strade costiere sono scarse e in pessime condizioni. Hoxha non voleva che questa parte dell’Albania fosse popolata, per evitare che la gente si mettesse in testa di nuotare verso Corfù, visibile in lontananza. Mentre camminavo lungo una delle spiagge, non si vedeva anima viva, ma tutt’intorno c’erano bunker di cemento e recinzioni di filo spinato, l’onnipresente firma di Hoxha. Ci vorrebbero investimenti massicci per far rinascere il turismo qui, ma si può fare.
Tornando verso la capitale dalla città costiera di Sarandë, ho attraversato un magnifico paesaggio punteggiato di ulivi e limoneti. A Vuno, un piccolo villaggio di montagna vicino alla costa, mi sono fermata a chiacchierare con una coppia seduta su una terrazza.
Potrebbero immaginare questo luogo come un parco giochi per ricchi turisti?
“Qui nulla è possibile”, mi ha detto la donna ridendo.
“Ma le cose stanno cambiando”, ho detto.
Lei rise di nuovo e mi guardò come per dire: “Tu non capisci”.
Suo marito mi lanciò uno sguardo interrogativo. “Che cosa è cambiato?”, chiese. “I nostri due figli sono in Italia. Lasciamo che cerchino la loro fortuna e che tornino con gioia. Questo è il nostro modo di fare”. In altre parole, ritenevano che per gli albanesi fosse ancora impossibile avere successo in Albania. Per loro la fortuna era un bene d’importazione, come per mio cugino Jack Kosmaçi.
Tornando a casa mia a Belgrado, ricordai la promessa fatta a Jack. Alexander era ancora detenuto in una prigione jugoslava, dove lui e altri rifugiati albanesi attendevano una revisione del loro status da parte dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Quando telefonai all’ambasciata statunitense, un funzionario consolare mi disse che Alexander non poteva ottenere asilo in America. “Perché non provi in Australia? O in Canada?”.
Il Canada ha accettato di prenderlo, così ho avuto il grande piacere di vedere Alexander liberato. L’ho portato a cena per festeggiare.
Tornerà mai in Albania?
“Mai!” Alexander disse. “Ho fatto un voto. I comunisti sono ancora al potere. Guardate i leader dell’opposizione, quasi tutti ex membri del partito”.
Era vero, ero d’accordo. Tutti coloro che volevano avere successo in Albania avevano fatto parte del partito, almeno formalmente. Ma il comunismo era ormai morto, la polizia segreta era sparita. Così come la vecchia Albania. La nuova Albania poteva essere diversa. Il popolo avrebbe esorcizzato il fantasma di Hoxha e iniziato qualcosa di nuovo, insistevo. Alexander rimase in silenzio. Lasciatelo andare, pensai, ha sofferto abbastanza.
È in partenza per una nuova vita in Canada, dove lo raggiungeranno la moglie e i figli. Quando l’ho detto al cugino Jack, mi è sembrato felice della buona notizia, ma non sorpreso.
Naturalmente: Avevo dato a Jack la mia besa.
































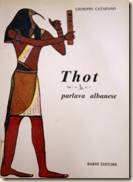

0 Commenti