Viaggio in Albania 1939 (2)
Viaggio in Albania[1]
Seconda parte
Fototesto del nostro inviato Lamberti Sorrentino
Tirana, dicembre.
L'aeroplano vibrò irregolarmente, cadde nel vuoto, sbandò; sotto l'ala inclinata a 45 gradi, Tirana, illuminata a chiazze da un sole smorto, è ferma nella oscura stretta della conca montuosa. Alle nove del mattino siamo partiti: alle undici siamo arrivati. Due ore appena uniscono le due capitali: quanto ne occorrono fra Roma e Milano. Questa vicinanza testimonia a favore dell'unione.
Stesi sull'aeroporto militare, venti apparecchi di guerra sono in fila, stranamente aggressivi sotto le spennellature delle tinte mimetiche. E subito dopo, le ruote del velivolo urtano terra; questo attorno è il solito aeroporto dell'Ala Littoria, organizzazione imperiale che si è sistemata a suo agio in ogni parte del mondo, e che funziona silenziosamente, come tutto ciò che è serio, che ha una meta esatta.
Per ultimo sono sceso: gli altri sono già assorbiti fra la gente che attendeva. A me è bastato un facchino, un albanese alto e asciutto, con baffoni che sanno certo di tabacco e rakì. È vestito alla rinfusa: pantaloni rammentati al ginocchio, una giacca che sembra un panciotto, aperta su una maglia di lana sfilacciata, con le maniche corte che lasciano scoperto un polso nodoso e due mani ossute e forti, anch'esse sformate dal lavoro, color mattone, due mani con le dita lunghe. Ha scarpacce inzaccherate ai piedi. Il portamento è libero e agile. Mi fissa con lo sguardo fermo. È un pover'uomo, che ha negli occhi la dignità propria delle razze forti. Occhi neri e grandi, che sanno incutere rispetto. Sul capo ha un fez bianco, acciaccato e unto. Quel fez e quegli occhi sono il primo incontro con l'Albania: un incontro che si ripeterà tutti i giorni, decine di volte al giorno.
Tirana è una città ridente, situata a 120 metri sul livello del mare; fu fondata al principio del secolo XVII, e vi risiedettero famiglie albanesi ricche; in seguito essa fu sede dei consolati esteri che lasciarono Durazzo per l'insalubrità del clima. È importante nodo stradale. Fu scelta da Zog a capitale del Regno.
L'albanese è un tipo d'uomo a sé. Gli spagnoli hanno un aggettivo particolare per certi volti: dicono: sufrido; vuol dire che ha sofferto, che ha sensibilità e speranze, che si è illuso e che ha avuto disillusioni. Quest'uomo è il testimonio vivo delle lotte fra oriente e occidente; ha tenuto la via aperta a questo nelle conquiste contro quello; si è serrato in difesa, ha ostacolato, ha fermato l'oriente allorché quel mondo, fissò gli occhi su Belgrado e Vienna, tentò la rivincita e l'invasione. Lo ha arrestato, ma subendone in proprio le calamità grandi risparmiate all'Europa intera. Quattro secoli ha subìto il turco; e croce e mezzaluna qui si sono scontrate e incontrate come nella Spagna avanti il Mille. Croce e mezzaluna si sono mescolate, hanno dovuto acconciarsi a vivere assieme e d'accordo. Questi due modi diversi di intendere la vita, hanno premuto la mano sulla coscienza degli albanesi, i quali, preoccupati per quello che veniva loro dal di fuori, non hanno potuto definire quello che sarebbe venuto loro dal di dentro. La modellazione è mancata.
— Sigaretta albanese? — chiede il facchino prima di prendere le valigie. Un facchino che offre da fumare non lo avevo ancora trovato; porge una scatola dove sono rimaste due sigarette — gesto rispettoso, pieno di dignità. Mi dà fuoco, soddisfatto della mia approvazione: — È buona. — Poi accende a sua volta. Questo gesto, l'offerta della sigaretta, mi accompagnerà per tutto il viaggio in Albania; lo schipetaro è ospitale, offre quello che ha; offrire è la sua ricchezza.
Tirana è la più occidentale delle città albanesi, perché la più moderna. Tuttavia vi sono architetture caratteristiche, motivi ornamentali che testimoniano i periodi delle varie dominazioni.
Il facchino guardò appena la mancia, non volle contarla. Mise i bagagli sull'automobile e mi salutò, con un sorriso da padron di casa. Lavora quel facchino, per guadagnarsi la vita; ma se la mancia era il suo scopo, il suo divertimento e la sua soddisfazione consistevano nell'aver saputo dare, ai nostri effimeri rapporti, un contenuto civile.
A Londra A Parigi, Berlino, Milano, Buenos Aires, i facchini dei porti e delle stazioni si limitano a intascar mance, se possibile copiose. Non hanno un viso. Questo, qui, a Tirana, nel portarmi le valigie ha saputo stabilire, precisare dei rapporti: tra lui albanese e me italiano. E non è dispiaciuto né a me né a lui.
A Tirana non ci sono stanze libere; gli alberghi sono pieni. Ho voluto arrivare come un turista, senza preavviso: ho avuto torto. — E avrai torto dovunque, in Albania, a presentarsi così — conclude un amico offrendomi un divano nel suo salotto.
— Questa consolle apparteneva al mobilio delle Principesse — aggiunge innanzi a un pretenzioso mobile indorato e laccato che non serve a nulla. Non riesco a posarvi nemmeno la mia macchinetta da scrivere. Pare che le tre sorelle di re Zog avessero una casa ricca, straricca; e dentro ci si annoiavano; incapaci di viverci completamente alla occidentale, così come gli impianti domestici avrebbero richiesto, non sapevano rinunciare ad abitudini tradizionali, derivate dalla religione musulmana. In quanto all’etichetta di corte è bene stabilire che si trattava di regole osservate quando conveniva. Questo è un po’ di tutte le etichette. Della famiglia di Zog ancora se ne sente parlare: dall’autista, dal conducente, dall’ufficiale arrivato qui con le prime truppe: si parla di Zog, furbo e incostante, delle tre “colonnelle” che giravano il mondo a spese dell’erario, di Geraldina. Sono accenni fatti con odio da coloro i quali credono, così, di rendersi interessanti al giornalista italiano.
Sono voci di curiosità, quella singolare curiosità olfattiva, tattile, tutta istinti, eguale in tutte le folle ammesse a frugare nei detriti della regalità. Anche giudizi gentili se ne sentono fare: su Geraldina e sull’amore, vero amore, che Zog ebbe per lei. Poi c’è il racconto monotono ormai e convenzionale sulla fuga della monarchia: casse d’oro, argenteria, vasellame prezioso, tutto l’erario in sostanza sopra gli autocarri che s’arrampicavano sulle montagne di Coriza. Sono discorsi che non interessano più; sono vecchi, si riferiscono ad un mondo che appare meschino comparato alle realtà attuali. Tutto il dramma di re Zog si riduce al pettegolezzo di una sottoprefettura. E ch’egli amasse le ragazzine, è un particolare che non serve più nemmeno a certe riviste francesi di storie e disegni piccanti. È tanto vero tutto questo, che il mio amico mai mi spiegò, ed io mai gli chiesi, durante una settimana vissuta assieme, come la «consolle» dorata e impennacchiata finisse nel suo appartamento.
Ecco un prossimo disoccupato: l'acquaiolo: l'acquedotto che fu inaugurato dal conte Ciano in agosto distribuisce l'acqua potabile a tutti i rioni della città.
M’ha detto il mio amico che in tutta l’Albania c’è crisi di alloggi. Le arterie del traffico albanese, che ai tempi di Zog si disseccavano nel disuso, sono tutte in turgore, gonfie da scoppiare, dopo l’arrivo degli italiani. Questo è il fatto nuovo della storia albanese. Gli stranieri che misero piede in Albania si limitarono ad occuparne i posti di comando; s’accontentarono del centro, trascurando la periferia. Gli italiani invece hanno dilagato dappertutto, sono andati nei paesini lontanissimi, lungo le valli acquitrinose, sulle montagne calve ed impervie, nei boschi del nord. In un paese d’un milione di abitanti, l’arrivo di centomila italiani — tanti sono tra militari e civili — esaurì ogni alloggio; ci fu la corsa all’appartamento e alla camera d’albergo. Con napoleoni e franchi oro i nuovi arrivati disputano la casa a quelli che li hanno preceduti. La casa diviene un affare; si riattano quelle vecchie, e ne fanno delle nuove. Tirana è tutta indaffarata nella calce, mattoni, pozzolana. Due operai trafficano pure nel giardino del mio ospite: un giardino un poco abbandonato, così come i giardini d’attorno. Le verdure nascono insieme con i fiori e le erbacce: in mezzo vi girano oche enormi e galline ben nutrite. Il fatto è che la casa fu costruita all’occidentale e mantenuta all’orientale.
A guardare di fuori questo rione, sembra di stare accanto a una città del nostro mezzogiorno; a metterci i piedi dentro, a circolar per i giardini, gli atrii, stanze e corridoi, si avverte che siamo agli orli dell’oriente. L’impressione è accentuata da una sparsa fragranza, un sentore di cucina forte, di grassi rigogliosi misti ad essenze vergini; un odore elementare ed eterogeneo, che sa di flit e d’olio di ambra, d’alcova e di montone stufato, di polvere insetticida ed estratto di rosa sparso senza economia su pelli e capelli. Si avverte solo il giorno dell’arrivo, questo flato che segna un confine attorno a quell’altro che si chiama, con espressione vaga, mondo occidentale. Poi non si avverte più; entra nei vestiti, nella pelle, fa parte di noi: il primo momento dell’ambientarsi.
Gli albanesi sono forti bevitori di caffè e di tè: ogni albanese beve una ventina di tazze di caffè al giorno in media, specie quelli della città, che amano permanere seduti lunghe ore a tavolino. Vi è un liquore nazionale, il “rakì”, simile alla grappa.
Anche le strade, specie quelle interne, i vicoli, ricordano l’oriente; quando piove tutto diventa palude: dalla fanghiglia affiorano pietre bianche, e bisogna saltare da una all’altra per attraversare i meandri che conducono alla via principale: qui c’è l’asfalto. Tutte le vie importanti di Tirana sono asfaltate: così la piazza grande dei ministri, con un giardina affossato nel mezzo, che sembra una piscina. Il profilo agile e armonioso d’una moschea s’intaglia contro il cielo oscurato da un fluire di nuvole. Quando il sole s’affaccia, le cose cambiano, le prospettive s’approfondiscono, la città diviene chiara. Un traffico allegro e serrato colma le strade: sono macchine americane, lunghe, Fiat d’ogni misura, alcune Lancia, autocarri e autotreni, e autobus. Un movimento che non ha nulla di fittizio. Per ogni auto almeno tre carrozze, più grandi di quelle nostre, con ruote cerchiate di gomma, che così furono un giorno. Il cocchiere sembra assorto in pensieri estranei alla corsa; va piano, non disturba il cavallo più assorto di lui. Dentro, vi si vedono ufficiali d’ogni grado, sott’ufficiali, soldati, signore che si rivelano italiane nel vestire e nel gesto, serie anziane che sorridono; ma se si vedono guardate negli occhi, ricambiano un sottinteso saluto da compatriote. Tutto e tutti entrano nelle carrozzelle tiranesi: anche le cameriere con la spesa, i facchini con le merci; un mezzo di trasporto facile e popolare. A volte, nelle strade, nelle carrozze, s’intravvedono donne musulmane col velo nero dal capo ai piedi. I negozi sono attaccati uno all’altro.
A guardare di fuori questo rione, sembra di stare accanto a una città del nostro Mezzogiorno; a metterci i piedi dentro, a circolare per i giardini, gli atrii, stanze e corridoi, si avverte che siamo agli orli dell’Oriente. L’impressione è accentuata da una sparsa fragranza, un sentore di cucina forte, di grassi rigogliosi misti ad essenze vergini; un odore elementare ed eterogeneo, che sa di flit e d’olio di ambra, d’alcova e di montone stufato, di polvere insetticida ed estratto di rosa sparso senza economia su pelli e capelli. Si avverte solo il giorno dell’arrivo, questo flato che segna un confine attorno a quell’altro che si chiama, con espressione vaga, mondo occidentale. Poi non si avverte più; entra nei vestiti, nella pelle, fa parte di noi: il primo momento dell’ambientarsi.
Anche le strade, specie quelle interne, i vicoli, ricordano l’Oriente; quando piove tutto diventa palude: dalla fanghiglia affiorano pietre bianche, e bisogna saltare da una all’altra per attraversare i meandri che conducono alla via principale: qui c’è l’asfalto. Tutte le vie importanti di Tirana sono asfaltate: così la piazza grande dei ministri, con un giardino affossato nel mezzo, che sembra una piscina. Il profilo agile e armonioso di una moschea s’intaglia contro il cielo oscurato da un fluire di nuvole. Quando il sole s’affaccia, le cose cambiano, le prospettive s’approfondiscono, la città diviene chiara. Un traffico allegro e serrato colma le strade: sono macchine americane, lunghe, Fiat di ogni misura, alcune Lancia, autocarri e autotreni, e autobus. Un movimento che non ha nulla di fittizio. Per ogni auto almeno tre carrozze, più grandi di quelle nostre, con ruote cerchiate di gomma, che così furono un giorno. Il cocchiere sembra assorto in pensieri estranei alla corsa; va piano, non disturba il cavallo più assorto di lui. Dentro, vi si vedono ufficiali di ogni grado, sott’ufficiali, soldati, signore che si rivelano italiane nel vestire e nel gesto, serie anziane che sorridono; ma se si vedono guardate negli occhi, ricambiano un sottinteso saluto da compatriote. Tutto e tutti entrano nelle carrozzelle tiranesi: anche le cameriere con la spesa, i facchini con le merci; un mezzo di trasporto facile e popolare. A volte, nelle strade, nelle carrozze, s’intravvedono donne musulmane col velo nero dal capo ai piedi. I negozi sono attaccati uno all’altro.
Continua…
[1] Tempo – Roma 21 dicembre 1939












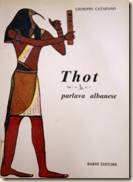

0 Commenti