Viaggio in Albania 1939 (3)
Viaggio in Albania[1]
Terza parte
Fototesto del nostro inviato Lamberti Sorrentino
Tirana, dicembre.
In ogni venti metri di strada, a Tirana, vi sono almeno dieci negozi: stretti, gonfi di merce e intasati di avventori. Nell'ora della libera uscita i clienti sono per tre quarti militari; gente allegra e talvolta chiassosa. Se ne vanno a gruppi, con il riso facile, parlando in coro. Vestono bene, questi nostri soldati, hanno scarpe pulite, volti glabri; certi ve ne sono che portano i guanti. Acquistare è una gioia e un divertimento: la tecnica del mercato orientale, i nostri ora la conoscono: tirano sui prezzi fino a ridurli normali, con una decurtazione del cinquanta per cento. Un'incipiente abitudine occidentale, quella del prezzo fisso, però, urta la dolce arte del comprare. I negozianti che hanno optato per il prezzo fisso, sanno esser crudeli: dicono no, no, senza muoversi dalla loro negazione; nel negozio accanto, invece, i prezzi sono precipitati dopo un accanito discorrere; e allora? I soldati se ne vanno, dubbiosi: sostano e si consultano sulla porta. Poi tornano, e comprano, agitati sotto lo sguardo impassibile del venditore a prezzo fisso, uomo che non si arrende. E così, a poco a poco, a forza di esperienza, si fa l'abitudine al paese, si conoscono persone e cose, s'impara a distinguere, ci si allontana dalla generalizzazione. Dopo un mese di permanenza il nostro soldato sa già tutto, non sbaglia, s'è intonato; d'istinto, in modo misterioso, egli è all'unisono con l'ambiente e con l'atmosfera; non un gesto, non una frase malaccorta e inadatta, si ripete due volte in lui; egli è perfettamente a suo agio e gli albanesi lo sono altrettanto con lui.
Dove arriva la strada, arriva la civiltà e l'assistenza; il medico della Milizia viene chiamato dalle famiglie albanesi che vivono in povere capanne per assistere i malati. Il medico della Milizia deve spesso camminare per chilometri e chilometri su sentieri accidentati, accompagnato dal suo barelliere.
Il soldato italiano fu in Spagna, e in Albania il miglior catalizzatore possibile tra l’idea che rappresenta e i popoli che lo accolgono. Dove egli arriva, si manifesta quale è, forte e gentile, attento a che lo rispettino, lui e il suo reggimento, ma a sua volta incapace di mancare di rispetto: dovunque arriva, il soldato o il legionario, nasce spontanea la fiducia in lui. E se si ha fiducia negli uomini, perché non averla nell’idea e nella loro terra? Il soldato italiano è ben trattato, ma non naviga nell’abbondanza; voglio dire che la sussistenza gli dà il giusto, non il superfluo; pure, quelli che lo hanno seguito in Africa, in Spagna, in Albania, sanno che egli è sempre disposto a dividere la pagnotta o la borraccia con chi ne ha meno di lui. A loro non costa fatica non rubare, non usar violenza, non ubriacarsi. Intendiamoci: non sono signorini, né primi della classe. Son pellacce: disposti a tutto, non rinunciano a niente. Se la domenica contassero i loro peccati al cappellano, questi ne udrebbe delle belle. Ma sanno il limite, ecco. Sono civili, sanno d’istinto dove si può arrivare, dove bisogna fermarsi. Hanno il senso sociale delle razze forti: il giusto diritto, che altro non è se non l’opposta faccia del giusto dovere.
Come va con le donne? — E i tre fantaccini che bevevano grappa al banco di un caffè, prima di rispondere, hanno voluto sapere chi fossi.
— Male, signor giornalista: in fatto di donne la va proprio male. La protesta sottintesa nasceva tutta da dentro, come dall’impeto contro una curiosa ingiustizia: — Che paese, accidenti! Nessuno di noi c’è, che abbia trovato l’amorosa. Qualcuno dice di aver fatta l’avventura: ma son storie. Chi ci fa niente, qui, con le donne? Gli albanesi stessi, se non si accasano, hanno voglia di fischiare! Non va. Peggio della Sicilia.
— Macché Sicilia! Io sono di Ribera — dice chiaramente un altro — in provincia di Girgenti: Ribera, comparata a Tirana, è una piccola Parigi, in fatto di donne, s’intende. Qui le vedi uscire, o col velo — e se ti avvicini senti che ti tremano sotto il naso — o a capo scoperto; e alcune son belle, altre ti fanno girare la testa, però non è niente, proprio niente da fare. E chi dice il contrario: bugie sono.
Giungemmo qui — annota il terzo — che sembrava un paese d’uomini soli; non ci conoscevano, e fecero sparire le donne; non se ne adocchiava una sola. Adesso hanno capito che gente siamo, non hanno più paura, di noi! E magari qualcuna un sorriso te lo allunga, la domenica, se nessuno la vede; a qualcuna un complimento glielo mormori, se nessun altro ti sente. Sapete che vi dico? Se le donne fossero compiacenti, io ci metterei la firma, a stare in Albania.
E questa fu una brutta notizia. Esagerano, pensai. Invece era vangelo; a viaggio ultimato m’è sorto il dubbio che non vi sia al mondo paese più difficile dell’Albania, da questo punto di vista.
Vorrei mangiare all'albanese, ho chiesto al ristorante; e m'hanno guardato stupiti, camerieri e clienti. La lista è all'italiana: nemmeno una voce locale. La verità è che vi sono due cucine: l'italiana e la francese: il resto è barbarismo, o tutt'al più modo di mangiare. Fra questi modi di mangiare, c'è anche l'albanese; una esperienza mia che narrerò tra poco. Qui a Tirana, a Scutari, a Còriza, a Valona, a Durazzo, alberghi e ristoranti annessi sono gestiti da italiani da quando si aprirono, e fanno da mangiare all'uso nostro. C'è il Chianti sul tavolo, anche se le marche sono strane e le etichette spesso sconosciute, forse improvvisate. Dove arriva il reggimento italiano, il giorno dopo arriva il fiasco di Chianti; il reggimento cambia posto, il fiasco rimane. Attaccati alle pareti vi sono bandiere e quadretti del Re, del Duce, di Ciano: le scritte sotto, sono in albanese. A un lungo tavolo d'angolo c'è un generale con il suo comando: una mensa provvisoria per mancanza di locali. Altri ufficiali, d'ogni arma e grado, sono nella sala. Quasi nel centro un gruppo di funzionari della Luogotenenza Reale; me lo confida il cameriere, che sono della Luogotenenza; quando lo chiamano a quel tavolo, vi corre con premura, e ad ogni ordine scodinzola, felice. Un barbuto prete ortodosso, rubicondo, importante, fa onore a tutte le portate, le ripete, e intanto gesticola, dà spiegazioni a un suo giovane commensale in borghese, sparuto, che annuisce rispettoso, e non leva gli occhi dal piatto: divora. Due signore vi sono, ancora in abito da viaggio, un poco pallide, un poco stanche, frastornate dall'ambiente nuovo, dalla vita d'albergo che s'inizia, dalla pioggia che vien giù, sordamente, e che obbliga alla camera, ne fa quasi una prigione. Anche due uomini in stivaloni mangiano con loro silenziosi. Hanno quasi l'aria di aver litigato, quei quattro. I trapianti sono amari da patire, ovunque. La donna più giovane prende dalla borsetta un pacchetto di macedonia: accende, aspira, assorta, poi soffia lentamente il fumo sulla brace.
È entrato, ora, un console della Milizia, saluta: da un tavolo altri ufficiali della Milizia si alzano in piedi, gli fanno posto. Quel gruppo costituisce lo Stato Maggiore della Milizia albanese, in formazione: quadri misti: truppa formata da volontari del luogo. Due bei fiaschi di Chianti in mezzo alla tavola, e un altro su quello accanto, dove quattro borghesi dai volti pallidi fumano con accanimento; due di questi sono musulmani, ma bevono anch'essi. Attenzione! Attenzione! il brusio cala di tono; e tra qualche sibilo, qualche interferenza, comincia la lettura del giornale radio. Molti hanno smesso di mangiare; ascoltano pensosi: da un momento all'altro potrebbe giungere la notizia nuova. È terminato il giornale radio. Nessuna novità. Ricomincia il tintinnio delle forchette nei piatti.
Le strade albanesi sono vive, quelle di città come quelle di gran traffico; non si fanno cinquecento metri senza trovare qualcuno. E a giudicare dal movimento stradale sembra, l'Albania, una regione super popolata. Donne, uomini, animali ad ogni passo; carri, autocarri delle colonne motorizzate — di queste almeno una al giorno; così che si comprenderà come si possa avanzare, in auto, soltanto a suono di sirena, con una media massima di 40 chilometri orari, se la strada è buona. Almeno per la metà questo traffico è costituito dalle maestranze addette ai lavori stradali. Imprese e dirigenti e specializzati, sono italiani: la mano d'opera è albanese. Decine di migliaia di fez bianchi lungo le strade: uomini, vecchi, ragazzi con le mazzuole, seduti per terra, a rompere la pietra in breccia. Squadre di cavatori sono sui fianchi delle colline a raccogliere la pietra viva, quasi sempre sul posto. Dove manca, la trasportano gli autocarri: file intere sono ferme a scaricare pietre in punti abbandonati, dove il fondo stradale non esiste più. In questi luoghi il lavoro comincerà appena le maestranze di un cantiere saranno disponibili. Tutti, ormai, quaggiù, si sono improvvisati manovali: anche i montanari hanno lasciato le loro kulle, attratti dalle buone paghe. In pochi mesi, il manovale è passato da tre lek al giorno — tre lire e settantacinque — a otto. All'inizio sono fiacchi, per denutrizione e per abitudine; ma il mangiare due volte al giorno li rimette, l'esempio li sprona; dopo una settimana danno un rendimento normale. Il risultato è sorprendente: l'albanese è pastore e guerriero, non operaio né agricoltore; però si adatta: basta persuaderlo, e va da sé.
Si procede alla distribuzione del bitume in un tratto di strada rinnovata, nella prossimità della capitale
Lasciando Tirana chiesi al mio amico una rivoltella; mi apprestavo a un lungo viaggio in macchina, dieci giorni per contrade sconosciute, per zone quasi vergini alla nostra penetrazione, con possibilità di arresti impreveduti, in campagna, di notte.
— Una rivoltella tiene compagnia, dissi, e insistetti. Il mio ospite rise.
— Prima di tutto ci vuole il permesso, e tu non l’hai; e poi dico che non serve. — Aggiunse: — Noi tutti giriamo disarmati. — È il mio amico, capitano dei carabinieri, uomo prudente per forza, e di sicurezza se ne intende per mestiere, ma mi sembrò spavaldo; non mi piacque. Mi tornarono in mente certe esperienze africane, momenti in cui si sarebbe dato un dito per una cartuccia. — Un matto si trova sempre, — brontolai in un tentativo estremo. Egli rise ancora: e anche il mio autista albanese mi ripeté in viaggio che “il signor capitano aveva ragione; briganti non ci sono più”. — Però ce ne sono stati. — Sì, ma in altri tempi. Ora, l’Albania è sicura come l’Italia. A esperienza fatta debbo aggiungere che è ugualmente ospitale e anche più. Una sola volta, in due settimane di viaggio senza meta precisa, mi accadde di bussare ad una porta, in campagna, per un guasto alla macchina. I padroni erano musulmani: come un ambasciatore mi accolsero, ed ebbero riguardi e attenzioni che, data la modestia della casa, mi sorpresero. Donne non se ne videro; ma gli uomini mi offrirono acqua fresca in un bicchiere di cristallo con gesti che me la fecero sembrare un liquido prezioso; poi caffè e dolci. La conversazione, a mezzo dell’interprete, si svolgeva intanto cerimoniosa e aulica. Avevo ammirato una ceneriera in filigrana d’argento; quando m’accomiatai, il padrone di casa me l’offrì in un modo che non permetteva rifiuti. — Si offende se non l’accettate; fategli anche voi un regalo, qualsiasi cosa, — suggerì svelto l’autista. Fu così che ricambiai con la mia stilografica; ed egli mi fece assicurare che lui e suo figlio avrebbero scritto con quella penna, ed anche suo nipote.
A Còriza saremmo giunti di sera; ma alle nove, contro la spalliera d’una foresta che s’aggrappava alla montagna, apparve un palazzo illuminato. — È un albergo termale, qui veniva la madre di Zog; vi sono anche mosaici di terme romane — m’informò l’autista. Desiderai sostarvi una notte, nell’appartamento reale. Si mangiava all’albanese in quell’albergo: tutta buona roba, forse, ma i grassi erano quello che erano: il nostro palato li respinge; non vi era burro in scatola, e nemmeno olio d’oliva. Mangiar un pomodoro crudo, a fette, con sale; e frutta. Rimasi così mortificato, che ripartii subito, rinunciando a visitare i mosaici romani e a destarmi la mattina nell’appartamento riservato un giorno alla regina madre.
Còriza è a venti chilometri dal confine greco, ed io vi giunsi ch'era giorno di mercato, in un falso disordine di piazzette e strade, in un apparente disordine di prodotti della terra e dell'artigianato esposti dappertutto. Se ci fosse stato il sole, ne avrei riportato una sensazione pittorica; ma pioveva un poco, e i colori si dissolvevano nella bruma vaga. Oggi questa folla e quelle cose mi tornano in mente come un’acquaforte di Frank Brangwin: folla e cose pigiate, ricche e in perpetuo moto; volti e forme di formaggio fresco, mani e scarpe, ventri e sacchi di legumi, petti e pezzi di stoffa, donne e asinelli, vecchi e mucche, bimbi e utensili: tutto è fuso da un contrattare tenace e inarrendibile. La sera, tornando dal confine greco, la rividi, questa folla, in un lungo e lontano corteo di asinelli carichi tra i quali la macchina si apriva il passo a fatica.
La strada che unisce Rogozhina a Lushja ha subito radicali modificazioni anche nel vecchio tracciato
Al confine, la presenza di un giornalista aveva determinato una piccola cerimonia. Il sottufficiale greco, comandante la stazione, era venuto da noi con una bottiglia di cognac macedone. Il maresciallo italiano ospitò la comitiva, e poiché il sergente è uno scrittore, si scambiarono brindisi su temi che spaziarono da Omero a Mussolini. Per quel sottufficiale poeta la conseguenza più notevole dell'unione fra Italia e Albania è il confine comune italo-greco.
— Queste nostre due divise — disse avvicinandosi al maresciallo italiano — stanno a dimostrare quanto affermo: siamo vicini, ci uniscono il passato e il futuro, i ricordi e i cognac.
Tutto questo del transito; in mezzo vi è scritto a grandi lettere: AIPA Azienda Generale Petroli Albanesi. Qui ho tutti i permessi; la sbarra si alza, e una guida monta sull'auto. C'è un viale alberato, ampio: alcuni chilometri, poi gli alberi cedono il posto a una foresta di torri metalliche. — I pozzi, — mormora la guida. Scende il tramonto, due nuvole si tingono di rosso, l'ombra s'addensa nell'intrico ferrigno. Le torri hanno invaso tutto il paesaggio; quelle vicine sono alte e imponenti, quelle lontane sembrano minuscole protuberanze della linea dell'orizzonte. La vettura corre silenziosa: estranea e impicciolita; tutto le è ostile; una di queste altissime armature metalliche si abbatterà sulla strada per polverizzarla, questa macchina intrusa. Siamo caduti in un mondo di ciclopi. Tra le innervature saettanti delle torri, si muovono, nella luce morente, uomini neri: ombre nell'ombra. Nella campagna buia il cielo si riflette con bagliori di perla. Due o tre stelle si sono accese: su ogni torre si accende una lampada, un coro di piccole lampade, improvviso, immenso: una fiammata subitanea: le architetture di ferro hanno tremato come sotto una raffica di vento. Alcune zone hanno ricevuto un'illuminazione supplementare: le lampade scoppiano come fuochi d'artificio, disegnando fantastiche losanghe. Poi sono le case che si mettono a guardare sulla piana dalle finestre accese. Dagli opifici dilaga l'incendio di immense vetrate. In cima alla collina, ci fermammo davanti ad una potente ed agile costruzione bianca: gli uffici. Porte a vetri, corridoi lucidi, legno naturale, legno naturale, ferro cromato. Un uomo in abito grigio e dall'aria modesta mi viene incontro: è il Direttore Generale. Foresteria: sorpresa. La sera è venuta, ora, intera: l'ingresso è illuminato, un alto cristallo smerigliato, un cameriere in giacca bianca, corridoi ampi; m'assegnano un appartamentino costruito e ammobiliato come la cabina d'un transatlantico: il divano che si trasforma in letto, il lavabo appartato e nascosto da una cortina scorrevole. Tutte le comodità, e niente sfarzo. — Il bagno è pronto, — annuncia la voce amica del cameriere. Un bagno con acqua regolabile, calda o fredda, con doccia, tappeti di spugna per terra ed enormi asciugamani candidi. È in questi casi che si è contenti di avere con sé una valigia fornita: radersi e mettersi in sicuro allieta, alleggerisce. Anche il mio ospite ha cambiato d'abito. A tavola ci sono un mio compagno di viaggio e l'ingegnere che ci accompagnerà domani a visitare la zona petrolifera, con i suoi pozzi e le sue raffinerie. La sala da pranzo è sospesa in cielo, come un belvedere; sporta sul ciglio della collina, è contornata da cristalli. La conversazione si svolge utile e cordiale, mentre il cameriere serve un buon mangiare di tutti i giorni, non d’occasione. Dalle vetrate s’intravedono le luci del campo; si sente palpitare la popolazione delle torri. La mattina all’alba partimmo alla scoperta della zona petrolifera. Vi è una guida accorta, eppure questo senso di scoperta diviene sempre più vivo. Un’ora dopo, al momento di tentare la definizione di questo congegno, diremo ch’esso è una collettività: una somma: tanti pozzi. Il dramma è da ricercarsi nell’antefatto, nell’opera degli ingegneri che attraverso esperienze, esperimenti, calcoli, giunsero all’invenzione e al perfezionamento di questa complessa macchina che è il pozzo di petrolio, montabile e smontabile in quattro giorni. Il pozzo non ha un diametro superiore al mezzo metro, alla superficie; nel vivo della terra, giù nella profondità di centinaia e centinaia di metri, si fa più stretto, appena perché il trapano possa lavorarvi. Quella del petrolio è una estrazione cieca: l’uomo non vi assiste, non entra sotterra, rimane alla luce del sole. L’uomo arriva al fondo della terra per mezzo di macchine che tagliano e comprimono; e dalla superficie, l’operaio sembra seguire visibilmente ciò che accade settecento metri sotto: la profondità dei giacimenti di petrolio. Un pozzo ha una sua nascita, una sua vita, un suo decesso. Quando la parte di giacimento sensibile all’azione estrattiva, non trabocca più, il pozzo è morto: lo si smonta e lo si trasporta altrove. Le torri sono immobili; osservate da vicino, si vede nel mezzo un piccolo stantuffo azionato da una corda di ferro che va su e giù, lentamente, continuamente. È la pompa, metodica. L’attività degli uomini si riduce a vegliare attentamente. Girando per il campo si scopre ogni tanto una piattaforma di terra smossa, con tracce profonde di violenze subite; per qualche tempo, lì, una armatura metallica altissima ha estratto instancabilmente l’oro nero: sei mesi, un anno, tre anni; poi la vegetazione è tornata a coprire le ferite, del pozzo non c’è che l’indicazione sulle mappe degli ingegneri. La vita degli uomini e delle macchine si svolge calma, regolata: sull’oceano nascosto di petrolio, una città si forma, dal telegrafo all’ospedale; appena l’ultima goccia del pesante liquido prezioso sarà finita nel condotto che arriva al mare, questa città svanirà: nata nel lavoro, cesserà nell’abbandono. Ma anni, anni, anni, anni, passeranno ancora.
Questo senso di transitorietà dà carattere alla vita che si svolge sul campo petrolifero. Vita semplice e misteriosa, che fa sentire al visitatore, alla fine della sua giornata, di essere stato nel petrolio, come si dice in gergo; nel nucleo di un mondo che vive per conto proprio, quasi appartato dall’umanità, ma al quale l’umanità deve la sua nuova epoca e il suo nuovo destino.
Per riattare il fondo della Librazdi – Còriza si usufruisce del brecciame ammassatosi sulle rive vicine
A Durazzo, due incontri: un uomo di mare con le idee precise, e un pioniere. L’uomo di mare abita una villa sul golfo. Al cancello, prima di entrare, mi presentò a un gruppo di signore italiane come potrebbero trovarsi in un salotto romano; parlano di tè, di bridge; soprattutto sanno di buon profumo. Sulla terrazza l’aperitivo: un marinaio in giacca bianca, un tavolo di pietra; si accentua la impressione di vita organizzata prodottami dall’incontro. Qui a Durazzo siamo a un punto avanzato dell’unione: la vita si è definita, o quasi: è superato l’urto del primo impianto, il primitivo, lo scomodo, ancora acuti a Tirana e altrove. La baia è bella come Napoli, così illuminata da uno spicchio di luna; si distinguono le navi da guerra nel porto: bellezza e potenza.
La parola regno, nel concetto degli orecchianti — dice il padron di casa — dilata le reali proporzioni dell’Albania; essa è l’equivalente d’una nostra regione, poco più grande della Sicilia, è poco più piccola del Piemonte. Ha nove fiumi: cinque perenni, con forti dislivelli: naturali bacini per il loro sfruttamento idroelettrico. La terra è buona: è fertile senza concime, animale o chimico che sia, ignoti agli albanesi. Il clima è simile a quello delle Puglie. Per i minerali, cromo ve n’è più di quello che ci occorre, e se ne esporta, petrolio ci copre per un decimo, ferro, per ora, per un quinto, carbone, rame, in quantità da precisarsi. Queste ricchezze affiorano nelle zone minerarie esplorate: un quarto dell’Albania. È presumibile che negli altri tre quarti, abbondino giacimenti di questi o altri minerali. Pastorizia dovunque: possibilità naturali superiori a quelle di una delle più ricche regioni italiane. Abitanti: un milione; il censimento stabilirà meglio. Convogliare le acque, bonificare le paludi, iniziare la coltivazione intensiva ed estensiva, sfruttare sistematicamente le miniere: quattro milioni di persone potrebbero viverci tutta la vita. Problemi politici non ve ne sono; gli albanesi sono contenti, l’unione all’Italia assicura ad essi la personalità civile e il benessere, a loro necessari.
Questo quadro sintetico dell’Albania mi venne fatto nell’agosto, durante la visita di Ciano. A viaggio ultimato, ora, non ho da aggiungere nulla.
La strada Fieri – Valona ha subito anch’essa modificazioni ed è stata consolidata in parecchi tronchi
Il pioniere l’ho trovato sulle paludi, presso la città dove sono in corso i lavori di bonifica: solo, intabarrato, con stivali di gomma, s’era fermato al limite della terra asciutta.
— A Durazzo ci venni nel 1913, e questa bonifica dovevo farla io — ha detto. Mostra quarant’anni, e ne dichiara di più, molti di più. Sa ricordare: — L’Italia conquistò la Libia, e, di riflesso, i turchi quaggiù tagliarono la corda. L’Austria sognò il canale d’Otranto e un re tedesco in Albania. Il principe di Wied assunse la corona di Scanderbeg e Durazzo ne fece una capitale. Addossate alle mura veneziane, casette di terra si diedero atteggiamenti di palazzi; la dogana si chiamò «konak» — palazzo reale; — in una notte nacquero alberghi in baracche squinternate e in capanne; prego: Grand Hotel Europa e titoli del genere. Per un napoleone d’oro, tutta la pensione: cibi tremendi. Un ungherese attaccò lampade a petrolio in cima a dei pali: l’illuminazione pubblica era assicurata. La gendarmeria albanese possedeva gambali neri, viennesi, ed era comandata da ufficiali olandesi. L’Inghilterra sostenne il prestigio della propria Legazione, mandando al suo ministro una casa smontabile. Per le nostre costruzioni non vi erano tavole né piani resistenti su cui piantare, ma fisse su travi: la capitale non faceva piangere né ridere.
Viene giù un improvviso scroscio d’acqua; il pioniere si addossa alla macchina, ma rifiuta di ripararsi dentro. Fuma e guarda la pioggia violenta sulla palude. Lo ascoltiamo sorpresi e interessati.
— Ma intanto tecnici austriaci protetti e secondati — continua il pioniere — invasero l’Albania; era la parte del leone che l’Austria si era riservata. Il personale della casa reale tedeschi della Baviera — garantiva via libera. Il commercio italo-albanese, da decine di secoli tradizionale tra i due paesi aveva perduto il suo vero significato, quello politico. Tutto era diventato avventura.
A questo punto l’autista ci avverte che bisogna far marcia indietro: il livello dell’acqua si alzò di un minuto in un minuto; non rimane che accettare la nostra ospitalità. Si torna, all’interno, per le paludi.
— Credo di essere il solo vero turista oggi in Albania, — dice sorridendo; — chi l’avrebbe detto, che sarei tornato qui come un turista. La vita è un’avventura. Ricordate la bene. — Qualcuno la tentò, l’avventura, nel 1913: l’ingegnere Quaglia di Torino ed io acciuffammo qualche appalto, concessioni venticinquennali. A bazzicare vittoriosamente per gli uffici ci aiutavano dei giornalisti italiani. Impianti industriali, costruzioni di strade; una corsa alle marce per i cementi, alle argille per i laterizi, ai calcari; dietro, sempre, gli austriaci, in concorrenza ostile, sistematica. I serbi offrivano il doppio; questo oggetto era ormai dell’attività italiana, prima ancora che nella automobilistica: la prima macchina a solcare Shkumbin fu una Fiat, con un numero d’auto alto per il re di Durazzo-Tirana, per 25 chilometri, e ventisei ore, senza strade, sul ponte di Sciak costruito con tralicci di bastoni. Le buche vicino al ponte, ora smetterete appena, avevano servito, secondo quanto ci narrarono, ai serbi per seppellirvi, con il capo fuori, le spie albanesi: così queste parlavano. Tirana non era che una Durazzo senza le mura veneziane; un bel minareto, un caffè all’aperto. L’ambiente non raccoglieva che la eco del dualismo italo-austriaco. Una torpediniera italiana a Durazzo vedeva giungere dopo poche ore, una o due torpediniere austriache.
Allora, sotto le finestre del Consolato austriaco, la notte, si cantava Trieste del mio cuore; venivano i gendarmi, andavano via noti; tre anni dopo, in grigioverde ripresa da noi e persa per gli austriaci.
Ha smesso di piovere; uscimmo all’aperto; il pioniere indica vagamente la palude, e dice:
Era concessione mia; ma al principe di Wied capitò addosso la rivoluzione dopo pochi mesi. Durazzo cominciò a sparare, i lampioni si spensero; gli stranieri si chiusero in casa a godersi lo spettacolo. Le mura veneziane si sbriciolarono un poco, non più adusate al cannone. E fu tutto. La monarchia se la batté a tempo, senza rimpianti; di questo regno vi rimasero i francobolli delle collezioni dei filatelici; nella storia, nulla; in me un ricordo che fu sopraffatto da altri avvenimenti, e mi sembrava seppellito; invece, dal giorno dell’unione, non mi dà più pace. Tanto che ho sentito il bisogno di tornarci, qui. Tutto in fermento, ho trovato: ieri per esempio ho potuto intrufolarmi tra la comitiva al seguito di Benini, il sottosegretario agli Affari Albanesi; visitavano i lavori di bonifica; io riuscii a piazzarmi proprio vicino a lui, a sentirlo parlare; mi sono divertito un mondo. È un uomo spiccio, e ne hanno fatto la prova quelli che lo accompagnavano; ce n’era uno, tarchiato e servizievole, che prendeva le cose per le lunghe, e gli faceva la teoria, gli diceva le parole tecniche. Ogni volta Benini lo interrompeva al momento giusto, con una battuta, una frase, da uomo della partita; parlava da industriale e da agricoltore, e mostrava di possedere nel suo lavoro quelle doti che, a parer mio sono il miglior complemento della tecnica: l’umanità e il buon senso. Gli ho visto prendere tre o quattro decisioni davanti a me; parla con accento toscano, e sa quello che vuole. A un certo punto mi guardò in faccia, con aria mezzo distratta e mezzo interrogativa: ebbi netta l’impressione che si stesse chiedendo chi ero, che mi sospettasse un intruso. Me la squagliai imbarazzato, ma soddisfatto. So che la palude, già bonificata in parte, fra poco lo sarà del tutto. E di fabbriche e industrie ne sorgono ogni giorno. Magnifico: non dico di no. Ma è facile — brontola tra i denti il pioniere — ora, con l’Italia che garantisce, e senza politicanti, senza dare bakshish, è facile prendere e realizzare iniziative. Oggi penso che eravamo pazzi, allora, a proporci di piantare una fabbrica di mattoni in questa pianura: se la guerra non ci cacciava, non starei qui a godermela, adesso: sotto la palude ci sarebbero i miei quattrini, ed anche le mie ossa.
[1] Tempo – Roma 21 dicembre 1939















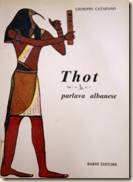

0 Commenti